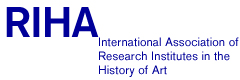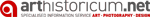RIHA Journal 0252 | 20 November 2020
Andrea e Jacopo Sansovino per gli Avis: i mausolei regali portoghesi nel contesto europeo
Abstract The article investigates the involvement of Andrea and Jacopo Sansovino in the planning of the burials of two Portuguese kings, D. João II and D. Manuel I. Starting from a new reading of the sources and the modern bibliography, it aims to reconstruct the chronology and events by relocating the sculptors’ activity and the ambitions of the Avis sovereigns to royal mausoleums beyond Portugal, from Spain, to France, to England. The article also re-examines drawing 142 A, which today is in the Uffizi’s Gabinetto Disegni e Stampe, questioning its supposed relationship with those projects and with both artists’ production under the patronage of the Lusitanian kings.
Indice
Monarchie continentali, scultori italiani e i sepolcri regali fra XV e XVI secolo O problema sansovinista: la presenza di Andrea alla corte degli Avis alla fine del Quattrocento Andrea Sansovino e le sepolture della corona, fra Batalha e Santa Maria di Belém Jacopo Sansovino e il progetto per un mausoleo del re di Portogallo Un disegno degli Uffizi e le perdute invenzioni per le tombe di D. João II e D. Manuel I Il pantheon degli Avis in Santa Maria di Belém nella seconda metà del Cinquecento
Monarchie continentali, scultori italiani e i sepolcri regali fra XV e XVI secolo
An art historian can approach the subject of these lectures only with the greatest trepidation. Trespassing upon the preserves of many adjacent disciplines […], he has to rely largely on secondary sources and often finds himself confronted with a diversity of opinions, at times about crucial points, which he, a rank outsider, cannot presume to evaluate.1
[1] Questo è l’incipit della prima delle conferenze pronunciate da Erwin Panofsky presso l’Institute of Fine Arts di New York nell’autunno del 1956, edite nel volume Tomb Sculpture: Four Lectures on Its Changing Aspects from Ancient Egypt to Bernini. La frase, posta in esergo alla comunicazione inaugurale ("From Egypt to the 'Tomb of the Nereids'"), riveste il valore di un monito; ed è vero infatti che la materia dei monumenti sepolcrali, connessa a un concetto ambiguo di temporalità (fra le urgenze del presente, l’eco del passato, un ambizioso sguardo al futuro) e sottoposta a una dialettica tesa con la Storia (o i suoi rovesci), si presenta fra gli interrogativi più stratificati per il ricercatore che intenda documentare la cultura visuale di un’epoca, di un luogo, di una classe sociale.
[2] È in fondo la stessa iconicità, implicita per complessi figurativi siffatti, a presentarsi come un difficile rebus: perché, insieme, le memorie funerarie aspirano a una sovrabbondanza di senso, in una rete allegorica composita, e a un’astrazione concettosa, legata alle prescrizioni di un’idealità esemplare. Basti qui rimandare alle diverse declinazioni – iconografiche e formali – del gisant o del transi, all’interno di una casistica ampia di varianti, imposte dalle esigenze di un naturalismo decodificabile (saldato mnemonicamente alle fattezze del defunto) o da quelle di una trasfigurazione eroica (favorita per magnificare le qualità intellettuali, umane, di censo del personaggio ritratto); oscillanti, insomma, fra la finzione di vita (spinta fino all’attivazione dell’effigie) e la dichiarazione del trapasso, fra la 'fotografia' di un cursus honorum e l’urgente obbligo di modestia ultramondana.2
[3] Per tornare alle parole del Panofsky:
[…] as biologists have had to recognize the fact that the principles of heredity and mutuation are complementary rather than mutually exclusive, so must historians accept the complementary relationship between continuity and innovation.3
Questo ammonimento apre la quarta e ultima sezione del libro e si colloca a preambolo del capitolo dedicato all’epoca moderna. Il principio di discontinuità è così ricondotto alla rivoluzione umanistica e rinascimentale, all’interno della quale, tuttavia, il volume – attorno al tema delle tombe – si sforza di individuare un durevole rapporto con la tradizione (o meglio, con le diverse tradizioni attive nella cultura mediterranea ed europea). Infatti, al di là di uno sguardo burckhardtiano sul Quattro e Cinquecento, trasparente in queste poche righe, è il legame con l’aspetto rituale – o cerimoniale, che dir si voglia – a complicare la materia dei sepolcri e del loro sistema significante, articolandone le variazioni e le permanenze. Le tombe, infatti, si inseriscono in una dinamica antropologica complessa, fatta di usi e credenze, connessi reverenzialmente alla dimensione della Morte (così come alle pratiche necessarie al suo esorcismo). Non di meno, pur instaurando un dialogo con un possibile altrove, partecipano delle relazioni sociali e politiche di una comunità, in grado di interferire con i costumi tramandati ab antiquo all’interno di quello stesso gruppo di riferimento.4
[4] Nello sguardo metastorico e nella classificazione tipologica seguiti da Panofsky con l’obiettivo di coprire oltre tremila anni di civilizzazione occidentale, trovano spazio cataloghi attinenti a canoni geografici, ad alternative strutturali o all’adozione di determinati motivi simbolici. Così, nell’articolato argomentare dello studioso, passano in secondo piano questioni relative alla committenza o alla fruizione dei monumenti; elementi in grado invece di suggerire ulteriori categorie, solo in parte sovrapponibili a quelle costruite per Tomb Sculpture.5
[5] In questo senso, una serie rilevante può essere individuata nella genealogia dei sepolcri regi in epoca moderna, in virtù soprattutto della loro dipendenza da ragioni liturgiche contraddistinte per durevole omogeneità. Da una parte, infatti, tale compattezza significa il senso di appartenenza di una popolazione di sudditi e si offre da immagine per un principio di governo travalicante limiti cronologici ristretti, in rapporto con le formulazioni del mondo greco-romano su legittimazione e propaganda. Dall’altra essa costituisce i medesimi sepolcri in quanto indici di continuità successoria e di competizione dinastica all’interno di una mappa estesa, di un contesto continentale in grado di abbinare esperienze su una gamma analoga di ambizioni e risultati.6
[6] Inoltre, per quel che riguarda la carica simbolica di complessi siffatti, è il confronto con un’insolita ricchezza delle fonti a caratterizzare lo studio delle tombe reali. Il rilievo delle personalità da essi celebrate moltiplica, infatti, le voci dei testimoni, garantendo un coro più affollato di notizie rispetto a quanto avvenga per commissioni private o di minor risonanza. Le loro strutture si articolano nel rapporto dialettico con un cerimoniale (quello dei funerali e della consacrazione, interrelati rispetto alla scomparsa di un sovrano), il cui concetto è condiviso dalla letteratura coeva (ad esempio la trattatistica politica o la poesia encomiastica), venendo sottoposto a uno scandaglio incessante rispetto al quale perfino le trasgressioni si prestano a verifica intellettuale, allo scopo di censirne occorrenze e moventi. Le memorie tangibili dei monarchi rimangono poi al centro di una cura continuativa, esorbitante il momento della loro ideazione e legata alle sorti della societas che le ha suscitate; e sebbene, in non pochi casi, tale pubblica rilevanza possa fomentare azioni aggressive ispirate a un vandalismo iconoclasta, la preminenza delle singole creazioni associa anche a queste perdite una scaletta emblematica, un discrimine preciso, un attento rispecchiamento nelle testimonianze erudite.
[7] In un’ottica siffatta, per quel che riguarda l’Europa fra Quattro e Cinquecento – in relazione alla concezione di rinascimento agita dalla letteratura rimontante al secolo XIX o all’inizio del successivo – ha nuociuto all’analisi del tema l’adozione di una prospettiva nazionalista, volta a mettere in luce le specificità patrie di ciascun monumento e la piena organicità di ogni struttura agli ambienti geografici di appartenenza.
[8] È utile qui menzionare il caso della tomba dei Re Cattolici, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, eretta nella Capilla Real di Granada nel primo quarto del Cinquecento, inclusa poi nel XIX secolo fra le opere dello scultore Bartolomé Ordóñez sulla base di un capzioso ricorso ai documenti noti7 (fino alla sua restituzione, nel 1891 e grazie a Carl Justi, al settignanese Domenico Fancelli);8 o ancora quello del sepolcro di Louis XII e Anne de Bretagne, progettato per la Basilica di Saint-Denis a partire dal 1516, il cui riferimento alla bottega di Michel Colombe è stato ribadito ancora negli anni Cinquanta dalle ricerche di Pierre Pradel, nonostante numerose notizie archivistiche – messe in luce da Giuseppe Campori9 e da Gaetano Milanesi10 – ne legassero l’esecuzione alla mano dei fiesolani Antonio e Giovanni Giusti.11
[9] Si tratta ovviamente di pensieri sorti in quadri bibliografici distinti, congegnati – secondo analoghe direttrici di senso – per rivendicare simboli eletti di un panorama nazionale ad ambiti di produzione autoctoni, nati cioè per depurare da influenze forestiere e allogene il delicato passaggio fra epoche diverse, quello circoscritto dalle categorie opposte di Gotico fiorito e di Rinascimento antichizzante.
[10] Tuttavia, in particolare se misurate sulle singole vicende mecenatesche, simili démarches dimostrano i limiti di uno schema riduttivo in termini geografici e cronologici. Proprio tali commissioni necessitano di venir collocate su uno scacchiere liberato dai confini ristretti delle identità nazionali e di esser reinserite nel coro polifonico della diplomazia cortigiana e della rivalità fra monarchie in competizione. Si tratta di un riposizionamento inevitabile, legato a un dialogo intessuto attorno a un comune spazio simbolico. Basterà riferirsi all’acre contesa attorno all’elezione imperiale che all’inizio del XVI secolo coinvolse le mire francesi e quelle spagnole per esemplare la contrattazione permanente di insegne e titoli lungo l’epoca moderna in un passaggio cruciale per il ripensamento delle potestates statali.12 Grazie a questa rete, fra Quattro e Cinquecento si disseminano – dalla Spagna alla Polonia, da corona a corona – figure, maestranze, opzioni iconografiche condivise o in polemico attrito, misurate da una parte su interessi politici contingenti, dall’altra sulla natura universale dell’autorità monarchica. A un medesimo fenomeno si associa poi la diffusione della koiné umanistica, agita da intellettuali (è il caso di Fra’ Giocondo al servizio di Charles VIII dal 1495), da poeti, da letterati itineranti (come Giovanni Michele Nagonio, Publio Fausto Andrelini, Cataldo Siculo, favoriti in vita da notorietà impensabili per un lettore odierno),13 provenienti per lo più da diversi contesti italiani e spesso arruolati nei ranghi compositi delle corti d’oltralpe al servizio delle urgenze encomiastiche di sovrani forestieri e dei loro entourage.
[11] Questo punto di vista sottolinea la stratificazione linguistica che soggiace alla concezione di tali memorie funebri: nel moltiplicarsi di referenti in un’ottica internazionale, le scelte di volta in volta operate in ciascun monumento assumono infatti un significato più pieno, mediando l’esigenza di una leggibilità sociale rivolta a fruitori differenziati. Anche la sopravvivenza di forme tradizionali va pertanto interpretata non alla luce di una declinazione passatista, ma piuttosto – nell’addizionarsi o nel sostituirsi a stilemi allogeni – come l’espressione di un’esigenza comunicativa, rivolta a un pubblico composito e intesa per sopperire a urgenze simboliche disparate, distribuite fra il bisogno di alludere alla continuità dinastica e quello di riferirsi alla scena politica coeva.
[12] Analogamente la parlata italianizzante, un registro ricorrente in monumenti siffatti grazie soprattutto al costante appello a maestranze tosco-emiliane (da Guido Mazzoni14 ai Giusti,15 da Pietro Torrigiano a Bartolomeo Berecci,16 da Benedetto da Rovezzano17 a Domenico Fancelli),18 andrà interpretata come un codice necessario per l’internazionalizzazione di simili strutture, in particolare nel contesto delle Guerre d’Italia e della contemporanea ridefinizione, fra XV e XVI secolo, dello scenario del Vecchio Continente: non un formulario di soluzioni e preferenze in concorrenza con le parlate gergali, ma piuttosto un vocabolario utile – su un fondale europeo – a veicolare significati politici, altrimenti inattingibili. Lo scontro bellico giocato sul composito campo di battaglia dello Stivale a partire dalla fine del XV secolo non aveva infatti solamente consentito alle élites continentali una diretta conoscenza dei fenomeni artistici e culturali fioriti da Milano a Napoli nei decenni precedenti: aveva anche creato un più ampio parterre di riferimento e aveva nutrito variegati interessi propagandistici, inediti fino a quel momento nel contesto delle esigenze diplomatiche delle corone in guerra.
[13] In questo senso, fra i molti casi esemplari, significativa appare la commessa formalizzata da Louis XII nell’agosto del 1502 per un sepolcro destinato ai propri avi, Louis d’Orleans e Valentina Visconti (assieme ai figli Charles e Philippe). La richiesta venne infatti rivolta ad artisti toscani e lombardi, proprio nei giorni in cui il sovrano aveva celebrato il suo ingresso trionfale a Genova nell’agosto del 1502, atto teso a formalizzarne il controllo sulla città. Sebbene la tomba fosse destinata alla chiesa dei Célestins a Parigi, la scelta di maestranze locali doveva, in quell’occasione, siglare di fronte ai nuovi sudditi il diritto ereditario che consentiva a Louis di affermare la propria autorità su una buona fetta di settentrione italiano (quello cioè garantitogli dalla linea viscontea); e il messaggio fu concepito a tal punto in una prospettiva pervasiva da affidare la redazione degli epitaffi per lo stesso sepolcro a Publio Fausto Andrelini, l’umanista forlivese trasferitosi alla corte di Francia già ai tempi di Charles VIII e confermato con molti onori nel seguito del suo successore.19
[14] Per la qualità delle esperienze mecenatesche perseguite dalla corona lusitana fra la fine del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento, il caso del Portogallo – capace di anticipare alcune delle successive tendenze continentali – riveste un’importanza in tutto distintiva. Nessuno degli Avis succeduti a D. Afonso V (1432–1481), e cioè D. João II – il figlio, noto anche come O Principe Perfeito, il cui regno, inauguratosi nel 1481, si concluse nel 1495 – e D. Manuel I – il nipote, conosciuto invece come O Afortunado (sovrano dal 1495 al 1521), si vide infatti onorato da una tomba maestosa (almeno prima della metà del secolo XVI, quando si arrivò finalmente alla costruzione di un pantheon dinastico a Lisbona). Tuttavia i progetti che si succedettero per compierne le sepolture testimoniano di dinamiche analoghe a quelle fin qui discusse, in un dialogo stretto fra Lisbona, Firenze, Roma e il resto del continente. Proprio una rilettura di questi episodi, alla luce di un panorama allargato che includa una casistica internazionale e guardi a diverse tradizioni bibliografiche, consentirà pertanto di ricostruirne le vicende secondo una scaletta aggiornata, sottolineando la coerenza con le biografie dei re portoghesi oltre che con la parabola creativa degli artisti coinvolti.
O problema sansovinista: la presenza di Andrea alla corte degli Avis alla fine del Quattrocento
[15] In termini cronologici, il caso del Portogallo, nell’intensificarsi dei suoi rapporti con il mondo artistico italiano, si colloca in anticipo rispetto al dialogo intrattenuto con lo Stivale dalle altre monarchie europee, cominciando dalla spedizione di Charles VIII alla conquista di Napoli nel 1494. A leggere infatti le Vite di Giorgio Vasari, l’episodio che qualifica tali relazioni in una prospettiva del tutto moderna si identifica con l’arrivo nel regno di Andrea Sansovino (ca. 1465–1529), scultore e architetto, marmoraro e plasticatore, una personalità in grado di incarnare il mondo delle botteghe fiorentine, proiettandolo in direzione del secolo XVI grazie a un rinnovato confronto con le lingue della classicità.
[16] Del resto, l’approdo di Andrea a Lisbona, in accordo con quanto raccontato dal biografo e sostenuto dagli studi recenti, avvenne quando lo scultore aveva dato prova di sé a Firenze nel cantiere della Sagrestia di Santo Spirito oltre che nella commessa, di esito ancora più felice, per la decorazione della Cappella Corbinelli, un patronato acceso nel transetto sinistro della stessa basilica agostiniana. Il viaggio dunque – che nel resoconto delle Vite fu sollecitato dal sovrano portoghese per la fama raggiunta dall’artista grazie a queste e altre imprese – andrebbe collocato alla fine del Quattrocento, stando all’aretino attorno al 1491–1492.20 Tale informazione è confermata dal contratto firmato il 9 dicembre 1492 insieme al compagno Bartolomeo di Ilario con Clemente Sernigi – in nome anche del fratello di questi, Girolamo, residente a Lisbona – relativo al trasferimento del maestro savinese al servizio del re D. João II.
[17] Il documento, pubblicato da Janez Höfler all’inizio degli anni Novanta21 (e già noto a Rafael Moreira, che lo aveva presentato nella sua tesi di dottorato),22 complica la narrazione offerta dal Vasari. Da una parte infatti testimonia di come in quella vicenda dovessero intervenire mediatori di primo piano, rappresentanti di una dinastia mercantile di origini toscane che proprio in Portogallo aveva radicato ingenti fortune, inserendosi nelle reti legate alle rotte asiatiche e atlantiche.23 Dall’altra, la cronologia del contratto mette in discussione l’azione diplomatica di Lorenzo il Magnifico in favore del Sansovino, denunciata a chiare lettere dalle Vite: il Medici, infatti, morto nell’aprile di quello stesso anno, potrebbe avere suggerito solo in un primo tempo il nome di Andrea, non arrivando a giocare un ruolo decisivo per la sua effettiva chiamata. Tale convocazione dovette invece finalizzarsi grazie al sistema commerciale (e finanziario) che da Firenze si ramificava in tutta Europa e il cui contributo è menzionato dall’aretino per altri celebri casi di esportazione di opere e di uomini, ad esempio nella congiuntura che portò Torrigiano e Toto del Nunziata in Inghilterra negli anni Dieci del secolo XVI.24 La rete commerciale fra Lisbona e la Toscana, d’altronde, era estremamente vivace già sulla metà del Quattrocento, come ha dimostrato una ben consolidata tradizione di studi: anzi, l’ingerenza sull’economia del regno di compagnie provenienti da Firenze e Pisa, fra cui i Da Colle o i Cambini, doveva essere a tal punto evidente da venir avvertita come una vera e propria emergenza, dibattuta a più riprese dalle Cortes fra anni Cinquanta e Ottanta.25
[18] Il contratto del 1492 legava i due uomini per un periodo di otto mesi a partire dal 15 dicembre, riconoscendo ad Andrea uno stipendio mensile di dieci fiorini (oltre alle spese di viaggio); e a tal punto simili condizioni appaiono vantaggiose – se confrontate con altre, analoghe determine contrattuali26 – da giustificare come il soggiorno dello scultore potesse tradursi in un rapporto mecenatesco prolungato – circa nove anni, secondo il Vasari – riconducibile (pur forse con qualche pausa) all’ultima fase del regno di D. João II (r. 1481–1495) e al principio del governo del suo successore. Sansovino, infatti, è attestato in Italia, più nello specifico in Toscana, nell’aprile del 1501, grazie a uno stanziamento di 25 fiorini stabilito il 15 di quel mese per l’avvio dei lavori sul nuovo fonte marmoreo per il Battistero di Volterra,27 circostanza che si offre come un termine ante quem per il suo ritorno in patria.28 Tuttavia, di una permanenza protrattasi così a lungo nulla rimane in termini di catalogo; nessuna notizia ulteriore contribuisce poi a determinare con esattezza l’attività dell’artista, a esclusione del ricordo grafico contenuto nel taccuino di Benvenuto della Volpaia relativo a una sega per pietre messa a punto dal Sansovino durante quegli anni.29
[19] A tal proposito va del resto sottolineato come il documento notarile sottoscritto da Andrea a Firenze lo leghi, con il collaboratore Bartolomeo, "in agendo et faciendo quodlibet opus in arte sculture et scultorum […] ut placebit eidem maiestati regie"; il racconto vasariano – che nel confronto fra le due stesure si arricchisce di un’inedita disamina relativa alle gesta portoghesi, certo frutto di indagini specifiche – lo vuole invece coinvolto in numerose imprese architettoniche, riconoscendo nella progettazione di edifici la sua principale attività al servizio della monarchia lusitana:
[…] lavorò per quel re molte opere di scultura e d’architettura, e particolarmente un bellissimo palazzo con quattro torri et altri molti edifizii; et una parte del palazzo fu dipinta secondo il disegno e cartoni di mano d’Andrea […]. Fece anco un altare a quel re, di legno intagliato, dentrovi alcuni Profeti; e similmente di terra, per farle poi di marmo, una battaglia bellissima, rappresentando le guerre che ebbe quel re con i Mori […]. Fecevi ancora una figura d’un San Marco di marmo, che fu cosa rarissima. Attese anco […], mentre stette con quel re, ad alcune cose stravaganti e difficili d’architettura, secondo l’uso di quel paese.30
[20] Cenni simili ribattono su un generale apprezzamento del suo profilo professionale in termini di progettazione architettonica promosso dal testo delle Vite del 1568 (ad esempio col rimando a un suo contributo per la messa in opera dell’antisagrestia di Santo Spirito, impegno che ha trovato una conferma solo parziale nella ricerca contemporanea).31 Tuttavia non appare improbabile che Sansovino nutrisse, già nella sua giovinezza, ambizioni differenziate rispetto a quelle tradottesi nelle opere che gli sono state confermate dalla corrente ricostruzione della sua attività acerba; e, in questo senso, non è nemmeno da escludere che il suo impiego alla corte di D. João II prevedesse una più ampia gamma di commissioni, in confronto a quelle alluse, magari per brevità, dalla stringata stesura di una formula notarile.
Andrea Sansovino e le sepolture della corona, fra Batalha e Santa Maria di Belém
[21] Risulta tuttavia difficile sottoscrivere senza esitazioni la proposta avanzata da Höfler, per la quale una delle principali commesse destinate ad Andrea al suo arrivo in Portogallo sarebbe stata la creazione di un sepolcro per D. João.32 Oltre che su una consuetudine mecenatesca diffusa a cavallo fra Quattro e Cinquecento presso le corti europee, tale suggerimento è basato sulla notizia, contenuta nella raccolta epistolare di Giovanni Gaetano Bottari, secondo la quale Sebastiano Resta avrebbe, alla fine del XVII secolo, posseduto un disegno d’ "un sepolcro d’architettura grande del re D. Gio. II di Portogallo, di mano del Sansovino vecchio", e cioè di Andrea.33 Il foglio – la cui qualità pare attestata dalle parole del Resta – deve oggi ritenersi perduto: è dunque impossibile giudicare l’attribuzione a esso legata nella lettera a Giuseppe Ghezzi, inclusa nel volume bottariano.34 D’altronde, qualora si opti per riporre fiducia nell’autorevolezza dell’erudito, difficile sarebbe stabilire la cronologia del progetto. Per Höfler, infatti, il riferimento andrebbe interpretato nel senso di una commissione affidata ad Andrea dallo stesso D. João.35 Tuttavia, a giudicare dal testamento del sovrano redatto il 29 settembre del 1495, sembra che l’Avis – a poche settimane dalla sua scomparsa, in seguito a una malattia – non avesse ancora disposto un piano specifico per la propria sepoltura; circostanza che confligge con l’idea di un coinvolgimento del Sansovino a queste date.
[22] Nel documento piuttosto dettagliato a cui il sovrano affidò le ultime volontà, la tomba è infatti menzionata solo in incipit, in coda alle rituali formule di introduzione:
Item minha sepultura quero que seja em o Moesteyro de Santa Maria da Vitoria no lugar e per a maneira que mais conveniente parecer a meu testamenterio e as cousas do descargo de minha alma lhe encomendo que se faça como lhe eu mando e as outras como lhe bem parecer.36 [Inoltre voglio che la mia sepoltura sia nel monastero di Santa Maria da Vitória, nel luogo e nel modo che apparirà più conveniente al mio esecutore testamentario, e ordino che gli uffici per la mia anima vengano eseguiti così come desidero e come possa apparire opportuno].
[23] Più a lungo i paragrafi seguenti prescrivono le messe da pronunciare per l’anima del monarca oltre che le opere di carità da questi ordinate agli esecutori testamentari: al contrario, per quel che pertiene al mausoleo, l’unica indicazione riguarda la chiesa designata per ospitarlo, il monastero domenicano di Batalha, destinazione per le sepolture dei re di Portogallo dai tempi di D. João I (Fig. 1).37
1 Mosteiro de Santa Maria da Vitória, Batalha, visione d’insieme (foto: Depositphotos)
[24] Proprio qui, d’altra parte, era stato interrato il corpo del giovane principe Afonso, erede al trono, morto a seguito di una caduta da cavallo nell’estate del 1491. Lo ricorda un epigramma di Cataldo Siculo, l’umanista attivo alla corte degli Avis, edito sia nel florilegio di sue Epistolae et orationes (1500) sia nella successiva raccolta Poemata (1501–1502), fra una serie cospicua di lamentationes dedicate al luttuoso evento:
Mortalis: qui totam spem in humanis collocas: lege/ queso casum hunc miserandum et inauditum. Alphon/ sus Ioannis Secundi regis et Lianore regine portugalie/ unigenitus: […] Summo mane in monasterium (quod belli dicitur) ubi cadavera regia reponuntur: allatum./ Solemnissimisque exequiis: ex omni regno confluenti/ Bus hominibus: sepultume et piissime ploratus. Ca/ Sus accidit mense iulii: die martis decimo tertio sta/ Tim post occasum solis: millesimo quadringentesimo/ Nonagesimo primo.38
[25] Al di là, dunque, della prevedibile preferenza per Batalha, che per via simbolica legava il monarca alla figura del bisnonno, il testamento non documenta l’esistenza di un progetto relativo alla sepoltura; e questo a meno di un mese dalla morte del re (avvenuta il 25 ottobre seguente), quando le sue condizioni di salute apparivano già compromesse. Sembrano attestare una situazione analoga i racconti dedicati agli stessi, luttuosi eventi da Rui de Pina (1440–1521) e Garcia de Resende (1470–1536), attivi a cavallo delle due reggenze che si susseguirono sul trono portoghese fra Quattro e Cinquecento.
[26] Il primo, infatti, nella Chronica d’el Rey D. João II – edita solo alla fine del XVIII secolo ma riferibile agli anni del suo incarico di "cronista-mor do reino" (funzione attribuitagli da D. Manuel I nel 1497) – ricorda come subito dopo la morte e la lettura del testamento ci si occupasse del corpo del sovrano:
E aa mea nocte foy ho corpo d’El Rey levado em huma Azemala a Silves, com grande pranto, e muita tristeza dos povoos que ali eram, e ho acompanhavam. E foy soterrado na Ingreja Maior […]; e d’hi foy despois treladado pera o Moesterio da Batalha per El Rey Dom Manuel nosso Senhor, ao tempo, e com a honra, e cerimonias, que em sua Cronica fara mençam.39 [E quella notte il corpo del Re fu trasportato su una cavalcatura a Silves con grande pianto e molta tristezza della popolazione che lì si trovava e che lo accompagnava. E fu sotterrato nella chiesa principale […]; e da lì fu poi trasportato al monastero di Batalha per volontà del re D. Manuel Nostro Signore, nel tempo e con gli onori e cerimonie di cui si parlerà nella sua Cronaca].
[27] Perfino su un piano metatestuale, nel rinvio a uno scritto futuro incentrato sulle gesta del successore di D. João, la responsabilità relativa al destino della salma viene interamente delegata a D. Manuel I;40 e, del resto, una medesima dinamica mecenatesca è delineata da Garcia de Resende nella Vida e feitos d’El-Rey D. João II, composta entro il 1545:
E aa mea-noite foy o corpo d’ el-rey levado em huna tumba cuberta de veludo preto, […] com muitas tochas aa See de Silves com muita tristeza e muyto grandes prantos dos senhores, e fidalgos, cavaleyros, e povos que ali eram & acompanhavam. E foy soterrado na ygreja mayor […]: & dahi foy depois levado ao Moesteiro da Batalha per el-rey Dom Manoel […] onde ora jaz seu corpo.41 [E quella notte il corpo del re fu portato in una bara coperta di velluto, […] con torce numerose a Sé de Silves con grande tristezza e molti pianti dei signori, dei cavalieri e delle persone che lo accompagnavano. E fu sotterrato nella chiesa maggiore […]: e da lì fu poi portato al monastero di Batalha per volontà del re Manuel dove ora giace il suo corpo].
[28] Certo si potrebbe sostenere che tali resoconti – composti tutti dopo la morte di D. João e nel clima ideologico di un nuovo regno – intendessero sottolineare, innanzitutto per un senso squisito della lusinga cortigiana, la pietà del successore e legittimare una linea di discendenza indiretta, costata frizioni e scontri all’interno della corte lusitana. D. Manuel, infatti, cugino del monarca e fratello della regina Leonor, era subentrato nella successione al trono grazie alla perdita che aveva privato la coppia dell’unico erede, il summenzionato principe Afonso; e tale nomina – ratificata dal testamento dell’Avis – era arrivata a sfavore di un altro figlio di D. João, e cioè Jorge, frutto dell’unione illegittima con Ana de Mendonça.42
[29] Tuttavia non si può dimenticare come – deceduto il re nel corso di un viaggio in Algarve – il suo corpo venisse provvisoriamente interrato nella cappella maggiore della cattedrale di Sé de Silves (luogo simbolico dell’indipendenza portoghese),43 per essere trasferito nella sede da questi indicata per la propria sepoltura soltanto nel 1499. La traslazione fu un atto politico, perfezionato attraverso un fastoso rituale nel quarto anniversario della morte, ricorrente nell’ottobre di quell’anno; ed è anzi significativo che nelle cronache contemporanee il momento dell’incoronazione di D. Manuel, celebrata nel 1495, passasse in secondo piano in favore del trasporto a Batalha della salma del re defunto.44 L’evento è descritto in testi diversi, venendo fissato anche in una relazione specifica a firma del Resende che ne arricchisce minuziosamente il racconto. Siamo dunque bene informati sul periplo che portò la salma fino al monastero domenicano, passando per diverse chiese e centri abitati.45
[30] Si può sottolineare come ci si curasse di compiere le ultime volontà di D. João a quasi un lustro dalla sua scomparsa. Tuttavia, ragioni diverse poterono indurre a una simile scelta, insieme dinastiche e pertinenti al tema più articolato del mecenatismo di D. Manuel nei primi anni del regno. Non è forse un caso che questi si preoccupasse del secondo funerale del suo predecessore solo dopo che, grazie al matrimonio con Isabel (figlia primogenita dei Re Cattolici), la sua stessa discendenza si era vista favorita dall’arrivo di un erede, Miguel (nato nell’estate precedente, il 24 agosto).46 Si tratta di una cautela seguita con una certa regolarità nelle committenze regali europee fra Quattro e Cinquecento e confermata, in anni prossimi al caso portoghese, dalle scelte di Louis XII di Francia e di Fernando de Aragón. Il sovrano francese infatti, al momento di richiedere nel 1499–1500 le sepolture di Charles VIII, suo predecessore, e dei figli di primo letto della sposa di entrambi, Anne de Bretagne, era stato favorito dall’ attesa gravidanza della moglie;47 lo spagnolo, per la comanda della tomba del principe Juan (affidata nel 1511 a Domenico Fancelli), avrebbe invece aspettato che la successione dinastica sul trono di Castiglia – complicatasi alla morte di Isabel la Católica – si fosse risolta nella designazione come erede ufficiale di Carlos de Habsburgo, figlio di Juana e di Philippe le Beau.48
[31] Del resto si può pensare che parte della dilazione fosse attribuibile al lento procedere dei lavori sull’edificio indicato da D. João, e cioè il monastero di Batalha.49 In particolare risultava incompleta la struttura di pianta ottagonale, fondata da D. Duarte nel 143750 con l’intento di farne il nuovo pantheon dinastico per la casa degli Avis (Fig. 2), in concorrenza con quella, più esigua, patrocinata nella stessa chiesa dal padre, D. João I, il sovrano che aveva stabilito la dinastia sul trono lusitano (Fig. 3).51
2 Mosteiro de Santa Maria da Vitória, Batalha, Capelas Imperfeitas, iniziate 1437 (foto: Depositphotos)
3 Mosteiro de Santa Maria da Vitória, Batalha, Capela do Fundador, 1426–1434 (foto: Depositphotos)
[32] Si trattava di due strutture disegnate da Mestre Huguet († 1438) fra terzo e quarto decennio del XV secolo, le quali però, nel loro succedersi in termini di cantiere, segnavano un incremento di scala nelle ambizioni della monarchia portoghese nel senso di un monumentalismo senza precedenti anche in prospettiva europea. La grande costruzione promossa da D. Duarte è in anticipo, ad esempio, sulla Lady Chapel progettata da Henry VII per l’Abbazia di Westminster a partire dal 149852 o sulla rotonda dei Valois, colossale addizione alla Basilica di Saint-Denis, il cui cantiere venne inaugurato solo nel settimo decennio del Cinquecento con l’intenzione di assolvere a una medesima finalità funeraria e celebrativa.53 D’altronde, l’architettura commissionata da D. Duarte era intesa per ergersi, assertivamente, alle spalle dell’abside, come una gigantesca rotonda con cappelle radiali (aggiunta a quelle di testata, già tracciate), forse sulla base di meno imponenti modelli spagnoli;54 così facendo assumeva pure in termini di pianta una preminenza sul sacello voluto da D. João I, addossato invece alla navata destra in prossimità della controfacciata, la cui posizione rispettava piuttosto le consuetudini costruttive proprie all’aristocrazia anglo-francese.55
[33] A causa dello stato d’incompiutezza della struttura alla morte di D. Duarte (avvenuta nel 1438), il sovrano defunto era stato sepolto nei pressi dell’altare maggiore, certo con la prospettiva di una seguente traslazione. Si deve dunque immaginare che i desideri di D. João II fossero rivolti a una medesima sede, sebbene negli ultimi anni del suo regno i lavori sulle cosiddette Cappelle Non Finite fossero avanzati con lentezza, nonostante la nomina a capocantiere di Mateus Fernandes nel 1490/1491.56
[34] Ridottasi l’attività costruttiva a Batalha prima della metà dell’ultimo decennio del secolo (ennesima circostanza che suggerisce come la propria sepoltura non fosse fra le urgenze del mecenatismo di D. João),57 l’attenzione regia tornò nuovamente a focalizzarsi sull’edificio solo a partire dall’esordio del governo di D. Manuel I, il quale nel 1497 avrebbe riconfermato a capo del cantiere l’architetto Fernandes.58 Significativamente il suo interesse avrebbe riguardato il sepolcreto voluto da D. Duarte, al quale fu garantita l’integrazione con lo spazio della chiesa nel tentativo di allinearne la funzionalità liturgica con le esigenze della comunità domenicana.59
[35] Non sarebbe dunque illegittimo supporre che in questo stesso tempo si cominciasse a meditare su una tomba per D. João, le cui spoglie andavano ricevendo i primi attestati ufficiali di virtù miracolose da parte delle gerarchie ecclesiastiche, ad esempio dall’indagine sollecitata nel 1497 dal vescovo di Algarve, João Camelo.60 La sontuosa cerimonia celebrata nella chiesa di Batalha all’arrivo del corpo (allusa secondo alcuni – ma senza che ci sia consenso critico al riguardo – da una nota miniatura del cosiddetto Livro de Horas de D. Manuel; Fig. 4)61 impone la necessità di un tale programma. È infatti difficile immaginare un diverso coronamento (almeno in proiezione futura) per le esequie, conclusesi con l’interramento del sovrano – certo in via provvisoria – nella cappella "de nossa señora do pranto", secondo le parole della relazione scritta sull’evento dal Resende.62
4 Livro de Horas de D. Manuel, ca. 1517–1538, scena di un funerale. Museu Nacional de Arte Antiga, Lisbona, c. 129v (foto: Museu Nacional de Arte Antiga, Lisbona)
[36] Guardando alla cronologia nota del Sansovino, viene pertanto da ipotizzare che il suo coinvolgimento nel progetto di una sepoltura per il monarca scomparso – se mai esso debba considerarsi effettivo, basandosi sull’unica attestazione bottariana – sia da collocarsi in questo frangente cronologico. Già Höfler, partendo da una nota archivistica contenuta nell’edizione delle Vite curata da Karl Frey all’inizio del Novecento,63 sottolineava come probabilmente la mobilità di Andrea fosse stata, nel corso degli anni Novanta, meno stanziale di quello che il medaglione biografico dell’aretino lasciasse supporre.64 Lo scultore poté infatti essere attivo a Firenze nel 1493, poi forse nel 1495–1496;65 e, se nel caso del primo rientro andrebbero spiegate le ragioni per cui il Sansovino fosse tornato in Toscana in maggio (con anticipo quindi sugli otto mesi di permanenza previsti dall’accordo firmato il 9 dicembre del 1492),66 in quello seguente la data potrebbe coincidere con la fase di transizione fra la morte del suo mecenate e l’avvio di regno del successore, consacrato il 27 ottobre del 1495.67
[37] Spiace semmai non conoscere con esattezza le intenzioni di D. Manuel al riguardo; e, allo stesso tempo, risulta difficile capire quale fosse il piano effettivo immaginato dal nuovo sovrano per Batalha e per il suo pantheon.68 Se da una parte infatti l’architettura maestosa delle Cappelle Non Finite rimase incompiuta nonostante il nuovo impulso dato alla fabbrica, i restauri e il culto storicista connesso al luogo (così come alle sepolture ivi contenute) rendono ancora più complesso interpretare le scelte operate fra Quattro e Cinquecento (Fig. 5).69
5 Mosteiro de Santa Maria da Vitória, Batalha, Capelas Imperfeitas, iniziate 1437, interno (foto: proprietà dell’autore)
[38] Si può tuttavia ricordare come, all’interno dello stesso edificio, potrebbe aver giocato un ruolo normativo per quel che riguarda la statuaria sepolcrale la Capela do Fundador, voluta da D. João I a partire dal 1426, uno degli ambienti della chiesa che nel corso del XVI secolo avevano raggiunto un qualche grado di finitezza.70 Proprio questo sacello traduceva infatti, nell’organizzazione spaziale dei suoi monumenti, un chiaro programma celebrativo, basato su una rigida idea gerarchica legata alle ramificazioni ereditarie dell’appena istituita dinastia degli Avis. Secondo un piano inaugurato nel suo testamento, D. João aveva previsto un mausoleo libero centrale per sé e per la moglie Filipa de Lencastre (sulla cui esemplarità nel panorama portoghese ci si è a lungo soffermati),71 relegando invece alle pareti, in una sequenza di tombe ad arcosolio, i depositi dei figli non destinati ad accedere al trono. Una griglia siffatta, tanto chiaramente delineata, doveva valere per i suoi successori, riservando alle sole tumulazioni dei re l’aula quadrata della cappella;72 e proprio difronte a tale soluzione, considerata anche l’esiguità del vano, venne formulata da D. Duarte I la proposta di un nuovo pantheon, quello appunto stabilito al di là dell’abside della chiesa. L’architettura della fabbrica incompiuta lascia immaginare che anche in questo caso si fosse pensato a sepolcri indipendenti per ciascun monarca, al centro delle cappelle radiali, e non piuttosto a tombe a parete, rispettando il paradigma imposto dalle scelte di D. João. È tuttavia difficile arrivare a conclusioni definitive, dal momento che l’ottagono si è consegnato imperfetto ai nostri giorni.73
Jacopo Sansovino e il progetto per un mausoleo del re di Portogallo
[39] Quello che è certo è che D. Manuel dovette presto perdere interesse nel cantiere di Batalha. Il 1509, data di completamento del grandioso portale immaginato da Fernandes per collegare l’ottagono alla chiesa, è infatti il solo puntello cronologico antecedente alla menzione del monastero contenuto nel testamento del sovrano, dettato il 7 aprile 1517. E sebbene le ambizioni nutrite in un primo tempo sul complesso siano dimostrate proprio dallo straordinario arco trionfale di gusto moderno (la cui concezione progettuale è dibattuta, pur tuttavia, fra le committenze dei due Avis), la lettera delle ultime volontà di D. Manuel non lascia dubbi su un radicale cambio di strategia mecenatesca, prodottosi fra primo e secondo decennio del secolo.
Recita infatti il testamento, in apertura:
Item minha vomtade he de minha sepultura seer no moesteiro de Nosa Senhora de Beleem deemtro na capeela moor diante do altar moor abaixo dos degraaos e que se me nam faça outra sepultura senam hununa campana chana de maneira que se posa amdar por cima dela.74 [Inoltre è mia volontà che la mia sepoltura sia nel monastero di Nossa Senhora de Belém dentro la cappella maggiore davanti all’altare maggiore sotto i gradini e che mi si faccia una lastra di modo che si possa camminare su di essa].
Prosegue poi, a distanza di diversi paragrafi:
Item roguo muyto e encomemdo que se mamdeem acabar as capellas da Batalha naquela maneira que milhor parecer que seja comforme a outra obra e asy lhe deem emtrada pera a igreja do moesteiro na milhor maneira que parecer e mamdeem mudar pera ellas seemdo primeiro de todo acabadas e asy seus altares e todas as outras cousas necesarias el rey Duarte que foy o primeiro principiador dellas e asy el rey Dom Afomso meu tio e el rey Dom Joam que Deus aja e o principe Dom Afonso meu sobrinho.75 [Inoltre chiedo che si concludano le cappelle di Batalha in quella forma che apparirà preferibile e conveniente e che si costruisca l’entrata dalla chiesa del monastero nel miglior modo e che vengano lì spostati, essendo prima di tutto concluse le cappelle con gli altari e tutte le altre cose necessarie, il re Duarte che fu il loro fondatore e il re Afonso mio zio e il re João che Dio lo abbia in gloria e il principe Afonso mio nipote].
[40] È evidente, nelle carte summenzionate, quanto la pur volenterosa dichiarazione d’intenti riferita al cantiere di Batalha (con le tombe da costruirsi in quel luogo per la linea di discendenza di D. Duarte I) si differenzi dalle specifiche relative alla sepoltura del sovrano in carica, destinata secondo quello stesso documento a venire ospitata nel monastero gerolamino di Santa Maria di Belém: una distanza che da sola sottolinea le nuove urgenze della committenza regia sul 1517. Da simili indicazioni traspare infatti un più articolato, inedito disegno genealogico, affidato a queste altezze cronologiche a un mecenatismo autonomo rispetto alle linee tracciate nel corso del secolo precedente dalla corona portoghese.76 Alla luce della sua controversa intronizzazione nell’ormai lontano 1495 e dell’inedita centralità rivestita sullo scacchiere continentale a partire dal secondo decennio del Cinquecento, D. Manuel sceglieva cioè di rivendicare un immaginario esclusivo, alla base di una personale successione dinastica.
6 Mosteiro de Santa Maria di Belém, Lisbona, esterno (foto: Shutterstock)
[41] Il monastero di Santa Maria di Belém (Fig. 6) era infatti strettamente legato al suo patronato già dal biennio 1495–1496, quando il sovrano – appena consacrato – ottenne dal pontefice Alessandro VI il permesso di fondare un cenobio gerolamino nella chiesa donata ai frati dell’Ordine del Cristo (Real Ordem dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo) dall’infante Henrique sulla metà del XV secolo.77 La comunità religiosa vi si sarebbe installata nel 1499, mentre la prima pietra del nuovo monastero venne posata nel 1500–1502.78 La Chrónica di Damião de Góis (1502–1574), edita negli anni Sessanta del Cinquecento, concorda con la di poco precedente Urbis Olisiponis Descriptio (1554) nell’affermare che la ricostruzione del complesso fosse stata intrapresa da D. Manuel "pera sua sepultura, & da Rainha Dona Maria; & de seus filhos".79 Tuttavia tale testimonianza sembra doversi interpretare come una ricostruzione a posteriori, affiancata del resto nelle fonti cinquecentesche o più tarde (fra cui ad esempio João de Barros o Frei Jacinto de São Miguel) alla motivazione che ne lega invece l’ambizioso ammodernamento al rientro dall’India di Vasco da Gama nel 1499 (o alla sua successiva partenza nel 1502).80 Stando alle ipotesi della bibliografia recente, la pianificazione del complesso ecclesiastico nelle forme di un pantheon personale potrebbe essere stata piuttosto formulata attorno al 1513.81 In questo tempo, infatti, si verificò un incremento della forza lavoro, in concomitanza col potenziarsi dell’investimento finanziario sostenuto dal monarca, tradottosi anche in un’estensiva campagna di acquisto dei terreni circostanti l’area edificabile coinvolta in un primo tempo dal cantiere. Del resto, forse anche alla luce di una decisione siffatta, lo schema generale della chiesa avrebbe subito una riformulazione radicale, vedendosi la sua progettazione affidata – a partire dal 1516/1517 – a João de Castilho (1470–1552), in sostituzione dell’architetto che aveva diretto fino ad allora i lavori, Diogo Boitaca (1460–1528).82 Nel contesto di un piano aggiornato va dunque ricondotta al 1517 la concezione da parte di Nicolau Chanterene (1470/1490–1551) del grande portale assiale, con il ritratto in veste di donatori dei sovrani (D. Manuel e la seconda moglie, Maria de Aragão), emblema esplicito di un patronato regio sull’edificio.83
[42] Il testamento del 1517 chiarisce dalle prime righe quanto il progetto relativo alla sepoltura fosse in quel momento ancora sotto scrutinio, lasciando però intravedere un non del tutto recente avvio della riflessione. La formula d’umiltà che esprime il desiderio di una lastra terragna – nella corsiva espressione di un regale understatement84 – evidenzia infatti come non si fosse giunti a una decisione definitiva da affidare agli esecutori testamentari, pur imponendo la collocazione da attribuire al monumento.
[43] A questo proposito è anzi necessario sottolineare quanto la volontà di posizionare la tomba "deemtro na capeela moor diante do altar moor" – una consuetudine rispecchiantesi in una più ampia tendenza continentale – imponga di ritenere che nelle intenzioni di D. Manuel si dovesse comunque provvedere alla costruzione di una struttura libera, non addossata a parete, intesa per venire ospitata in posizione preminente nello spazio qualificato della cappella maggiore.
[44] Una cronologia come quella qui sopra tracciata, stretta fra le date del 1513–1514 e del 1517 e tuttavia aperta a sviluppi susseguenti, rimanda alla notizia contenuta nell’edizione giuntina delle Vite vasariane (per l’esattezza nel medaglione dedicato a Niccolò Tribolo) relativa al tentativo – animato in Italia, fra Roma e Firenze – di fare allogare a un artista autoctono "per lo Re di Portogallo una sepoltura di grandissimo lavoro". Tale manovra mecenatesca avrebbe coinvolto Jacopo Tatti, grazie alla mediazione di Giovanni Bartolini, "per essere stato" lo scultore "discepolo d’Andrea Contucci dal Monte Sansovino et avere nome non solo di paragonare il maestro suo […] ma d’aver anco più bella maniera"; si sarebbe infine tradotta nell’esecuzione di un "superbissimo modello di legname, pieno tutto di storie e di figure di cera".85
[45] La letteratura specialistica dall’inizio del secolo fino a tempi recentissimi ha diversamente collocato un simile evento, optando di volta in volta per il secondo o il terzo decennio del secolo decimosesto, e il dibattito ha pertanto generato più di una discrepanza nelle ricostruzioni critiche proposte in bibliografia. Questionata è stata perfino l’intestazione del monumento allusa dal biografo nel rispetto di una qualche genericità: ci si è cioè a lungo chiesti se esso fosse stato inteso per celebrare la memoria di D. Manuel o piuttosto quella del suo predecessore.
[46] La discussione è stata inaugurata nel 1909 da Laura Pittoni, la quale nella sua monografia dedicata a Jacopo Sansovino ricorda la commissione del modello, secondo la testimonianza vasariana, riconducendola agli anni immediatamente successivi all’ingresso trionfale di Leone X a Firenze. Nel dar conto della commessa, il volume ritiene – seppure in via ipotetica – che la tomba fosse intesa per D. João II "sepolto a Batalha in Portogallo nella cappella de Nossa Senhora do Pianto, ora N. S. de Piedade".86 Senza commentare quest’opinione, sarebbe tornato sul tema Guido Battelli, negli anni Venti lettore all’Università di Coimbra e voce del nazionalismo italiano in quell’ateneo.87 Lo studioso infatti sostenne un’estenuante dibattito attorno all’attività e al ruolo di Andrea Sansovino in Portogallo, pubblicando in materia diversi contributi (in entrambe le lingue), in un dialogo serrato con storici e intellettuali lusitani, fra cui Vergílio Correia e Francisco Augusto Garcez Teixeira. Proprio nel corpo dei suoi interventi ebbe modo di riflettere sulle sepolture reali portoghesi, senza però giungere a soluzioni condivise o in grado di orientare la letteratura successiva verso un esito storiografico collegiale.88
[47] È merito di Ulrich Middeldorf una più articolata messa in contesto del problema, condotta in un tempo in cui lo studioso interrogava in maniera estensiva l’attività delle botteghe di Andrea e Jacopo, nel triennio compreso fra il 1933 e il 1936. Risale in particolare a quest’ultimo anno un articolo apparso su Rivista d’arte, nel quale Middeldorf fa riferimento alla commessa ricevuta dal più giovane fra i due; tuttavia il testo non si sbilancia né sulla collocazione cronologica dell’evento, né sull’identità del defunto, accontentandosi di ricordare come il Vasari facesse accenno soltanto a un "Re di Portogallo".89
[48] Anche Mary D. Garrard, nella sua tesi di dottorato dedicata alla produzione giovanile di Jacopo Sansovino e discussa nel 1970, si sarebbe espressa al proposito: la studiosa credeva che il Tatti – sempre seguendo le parole di Vasari – fosse stato coinvolto fra il 1514 e il 1518 nella progettazione di una tomba per D. João II, per la quale appunto avrebbe approntato un modello, ricorrendo – secondo l’aretino – alla collaborazione di Tribolo (circostanza fondamentale per la cronologia della commessa).90 Tuttavia, in una nota, la Garrard sottolineava quanto l’ipotesi in favore di una sepoltura per D. Manuel I dovesse ritenersi altrettanto viabile, rimessa in discussione soltanto dalla già citata testimonianza del Resta.91
[49] Nel 1983 Rafael Moreira avrebbe sottoscritto l’idea di una tomba per D. João II disegnata da Jacopo dopo il 1517 sulla base di un precedente pensiero di Andrea;92 e tale opinione sarebbe stata ribadita dallo studioso ancora nel 2001, in un contributo pubblicato sulla Revue de l’art.93
[50] La medesima questione era stata però approfondita, all’inizio degli anni Novanta, dal summenzionato articolo di Höfler, il quale (per evidenti ragioni editoriali) non aveva potuto tenere in conto il diverso avviso formulato in un contributo edito appena un anno prima, e cioè la monografia di Bruce Boucher dedicata a Jacopo Sansovino nel 1991. Tale studio, riassumendo le posizioni precedenti, arrivava alla conclusione che il Tatti fosse stato interpellato per un monumento destinato a D. João o a D. Manuel, sostenendo però che l’esecuzione del modello andasse collocata sul 1521–1523, quando l’artista si era trasferito nuovamente a Roma da Firenze.94 Höfler, al contrario, avrebbe proposto che la maquette prefigurasse una tomba da costruirsi in memoria di D. João II (la conseguenza diretta di un’invenzione abortita del maestro di Jacopo, Andrea); tuttavia, per quel che riguarda la cronologia della vicenda, si sarebbe piuttosto espresso in favore del 1515, certo sulla base della pagina vasariana.95
[51] Riconoscendo nella necessità di provvedere a un sepolcro per la monarchia lusitana il primo movente del viaggio di Andrea, Fernando-Jorge Grilo aveva però ripreso, nel 1994, la ricostruzione del Battelli, individuando nella commissione di D. João per una tomba dedicata al principe Afonso il motore della chiamata a corte dello scultore.96 Una simile opinione non è stata seguita dalla letteratura successiva. In particolare, Gabriele Fattorini, nel 2013, ha sottoscritto sia la data avanzata da Höfler sia l’identificazione del defunto;97 mentre Alessandra Giannotti, nella voce dedicata al Tribolo nel Dizionario Biografico degli Italiani, ha abbracciato la soluzione di Boucher in favore degli anni Venti, lasciando cautelativamente insoluta la doppia ipotesi sull’ideale destinatario della tomba.98
[52] In questo senso una lettura sinottica della biografia manuelina e della pagina delle Vite può forse contribuire a proporre una scansione coerente degli eventi, a un tempo inserendo la commissione al Sansovino in un quadro storico articolato.
[53] Il brano vasariano è piuttosto chiaro nel legare la richiesta a un momento specifico dell’esistenza di Jacopo, quello cioè vissuto in Toscana, quando – quasi compiuti i lavori finanziati dall’Opera del Duomo (per l’Apostolo destinato a Santa Maria del Fiore) e da Giovanni Bartolini (per il quale stava scolpendo il Bacco oggi nelle collezioni del Bargello) – l’artista si dedicava alla commessa di Giovanni Gaddi per "un camino et un acquaio di pietra macigno". Siamo nel quinquennio compreso fra il 1510 e il 1515, in prossimità della scadenza di un simile lasso temporale.99
[54] Proprio il Bartolini, il più generoso fra i mecenati toscani dell’artista, gli sarebbe anzi servito da tramite nel conferimento dell’incarico per il Portogallo, in un periodo in cui il Tatti era al centro di una bottega popolosa, atta a sostenere un carico impegnativo di ordini. Vasari chiarisce infatti come, alla realizzazione della maquette, prendesse parte il giovane Niccolò Tribolo, al tempo in cui questi operava fra i collaboratori dello scultore. L’aretino sottolinea anzi che, in virtù della fama raggiunta con una commessa tanto importante (per la quale provvide "storie e […] figure di cera"), Tribolo "partito […] dal Sansovino" avrebbe intrapreso una carriera autonoma, favorita in un primo tempo dal sostegno di Matteo Strozzi.100 Stando alla lettera delle Vite, il progetto plastico andrebbe quindi collocato in una cronologia prossima a quella accolta da Höfler: nato nel 1497, Niccolò poteva avere allora circa diciotto anni e veniva da un training sotto la guida del padre, seguito da quello al servizio di Nanni Unghero, prolungatosi per un triennio.101 È d’altronde la stessa qualità dell’intervento riferito a Niccolò a rendere credibile il racconto delle Vite; più difficile sarebbe infatti immaginare che Jacopo – le strade dei due artisti essendosi già divise all’inizio degli anni Venti – ricorresse a un contributo esterno alla bottega per un impiego come la modellazione di micro-sculture da associare alla maquette lignea del sepolcro, in un certo senso rinunciando alla possibilità di una supervisione diretta. Tale operazione doveva infatti qualificare l’intera struttura in termini di autografia sansovinesca, se si considera quanto il maestro fosse esaltato nella comunità fiorentina per i suoi pensieri affidati a materiali plastici, celebri sin dai primi anni di attività.102
[55] Una datazione attorno al 1514–1515 cade in una fase significativa nell’arco lungo dell’azione mecenatesca manuelina, e cioè nel momento in cui il sovrano stava reindirizzando la propria committenza verso il monastero di Santa Maria di Belém, intendendo farne un pantheon dinastico personale distinto da quello, più antico, di Batalha.103 Appare dunque evidente che l’intervento di eventuali mediatori toscani (in primis del Bartolini), in contatto con l’ampia rete finanziaria e mercantile che legava Firenze al resto d’Europa, doveva incardinarsi a tali proponimenti, cercando di venire incontro ai desiderata più urgenti del re. Nell’ambiente cittadino si poteva essere bene informati sugli orientamenti e sulle iniziative della corte lusitana grazie a figure come quella del plenipotenziario Bartolomeo Marchionni, nelle grazie di D. Manuel I, il quale rivestiva un ruolo fiduciario per le questioni concernenti la sfera artistica e culturale.104 Andrebbe allora escluso che Jacopo si incaricasse di formulare un disegno per la sepoltura di D. João II, impresa ormai uscita dalla lista delle priorità dell’Avis: non si giustificherebbe altrimenti la proposta di un’opera "di grandissimo lavoro", per tornare alle parole del Vasari, la quale certo non avrebbe incontrato la disponibilità finanziaria del monarca.
[56] Non va neppure sottovalutato come nel marzo del 1514 D. Manuel avesse goduto del suo momento di massima esposizione sulla scena italiana, grazie all’ambasciata giunta alla corte di Leone X e guidata da Tristão da Cunha, insieme al rappresentante della corona residente a Roma, João de Faria; una vera e propria apoteosi della gloria oltremarina portoghese, il cui controllo sulle rotte afro-asiatiche si dimostrava ormai saldamente stabilito (grazie a roccaforti come Goa o Malacca) e che nella Città Eterna riceveva la benedizione del potere pontificio.105 Non a caso, proprio a seguito dell’importante evento diplomatico (durante il quale fu pronunciata da Diogo Pacheco un’oração de obediencia, specchio dello scambio epistolare fra Leone e il sovrano intensificatosi nel corso di tutto il 1513),106 il papa avrebbe omaggiato D. Manuel con una seconda rosa d’oro, inviata in aprile dopo quella consegnatagli da Giulio II nel 1506: una regalia che, nel linguaggio politico del Cinquecento, riconosceva il pio zelo di un re nella difesa e propagazione della fede cattolica.107 Non sarebbe stato questo l’unico dono indirizzato all’Avis, in un crescendo inteso per accompagnare l’emissione consequenziale di una serie di bolle e brevi pontifici, tesi a soddisfare le richieste rivolte dal re. L’invio di un libro di musica, fatto preparare dal cardinale Giulio de’ Medici per garantire la pace dell’anima del monarca, sarebbe così seguito a quello di un camino in marmo bianco, offerta menzionata da alcune voci bibliografiche anche recenti.108
[57] Un simile focalizzarsi di interessi diplomatici fra il Medici e il Portogallo è una circostanza da tenere in considerazione in rapporto all’annosa questione della sepoltura di D. Manuel. Si può infatti ricordare come – in conseguenza di un assimilabile scambio di epistole, ambasciatori e doni, suscitato dalla redazione di una difesa della Chiesa cattolica in chiave anti-luterana (l’Assertio Septem Sacramentorum) per mano di Henry VIII di Inghilterra – si sarebbe giunti a proporre al Tudor alla fine del 1521 tre modelli di sepoltura, preparati fra Firenze e i palazzi vaticani dallo stesso Sansovino, da Baccio da Montelupo e da Baccio Bandinelli.109 Quest’ultima vicenda è stata al centro di un interesse crescente, che ne ha chiarito intendimenti e prospettive culturali. Gli studi hanno messo in luce quanto l’idea di soddisfare il risaputo desiderio del sovrano, rivolto a provvedere per sé una tomba grandiosa, nascesse in realtà come il compimento di un progetto insieme politico e mercantile, sollecitato dalla curia leonina in parallelo con la compagnia commerciale Bardi-Cavalcanti, attiva fra Londra e la Toscana. Nel momento in cui Henry rivendicava un’inedita visibilità sulla scena italiana – vedendosi attribuire, da parte del pontefice, il titolo di Defensor fidei grazie all’azione del suo ambasciatore residente, John Clerk110 – si sceglieva cioè di rimunerarlo con un bene avvertito come mediceo e fiorentino, con un prodotto della squisita cultura artistica toscana. Tale riconoscimento veniva dunque declinato in un genere (quello del monumento sepolcrale) che si stava diffondendo proprio allora fra gli ottenimenti imprescindibili per il prestigio di una corte europea, dalla Francia alla Spagna, da Saint-Denis alla Capilla Real di Granada.
[58] Si potrebbe quindi pensare che l’offerta a D. Manuel del progetto di una tomba – stando alle parole del Vasari un’azione di chiara provenienza italiana – nascesse in un ambiente e in un clima analogo, suscitati proprio dalla spedizione diplomatica del Da Cunha nel marzo del 1514. Questo giustificherebbe il coinvolgimento di un uomo come il Bartolini, rappresentante della stessa oligarchia mercantile coinvolta più tardi (e in un ruolo di primo piano) nell’invio indirizzato a Henry VIII. Perfino il lessico vasariano suggerisce una comunione d’intenti fra il mausoleo sottoposto all’attenzione del re di Portogallo e almeno uno di quelli spediti al Tudor. Se infatti per la prova di Sansovino le Vite parlano di una "sepoltura di grandissimo lavoro", "un superbissimo modello di legname pieno tutto di storie e figure di cera",111 il biografo descrive la maquette eseguita dal Bandinelli come un "bellissimo modello di legno e le figure di cera per una sepoltura".112 Nel caso dunque che la sequenza cronologica qui formulata fosse accolta, si dovrebbe pensare che la proposta indirizzata a D. Manuel costituisse un precedente per quelle sottoposte a Henry, le quali – ugualmente – non avrebbero trovato una loro coerente messa in opera. Del resto, va ricordato come – secondo una concatenazione opposta – D. Manuel si sarebbe visto omaggiare dal pontefice del pileus ducale e del gladius papale il 27 dicembre del 1514,113 quando il Tudor aveva ricevuto il medesimo dono solo un anno prima, nel Natale del 1513.114
[59] Una datazione simile ribatterebbe su un progetto più ampio, perseguito dal re di Portogallo in quegli stessi anni; progetto che ebbe un riflesso sia sul piano del mecenatismo letterario sia su quello monumentale. Mentre infatti il sovrano aveva ordinato la compilazione di nove cronache dei suoi predecessori a umanisti come Duarte Galvão o Rui de Pina,115 si stava anche preoccupando di ridecorare alcune delle loro memorie monumentali. È il caso delle tombe di Alfonso Henriques e Sancho I nella chiesa di Santa Cruz a Coimbra (Fig. 7), un tempio la cui architettura era stata reimpostata da Boitaca a partire dal 1507.
7 Nicolau Chanterene, Tomba di Sancho I, 1518–1520, Igreja de Santa Cruz, Coimbra (foto: Foto Marburg)
[60] Le due strutture ad arcosolio (immaginate attorno al 1518 da Nicolau Chanterene per essere collocate nella navata e solo in un secondo tempo mosse in direzione dell’abside) dovevano riattualizzare il ricordo della monarchia lusitana delle origini, riconnettendo la discendenza indiretta di D. Manuel a una più lunga e continuativa tradizione regia, che, in qualche misura, scavalcava a ritroso i nomi dei suoi antecessori più prossimi.116
Un disegno degli Uffizi e le perdute invenzioni per le tombe di D. João II e D. Manuel I
[61] Al di là della sua eventuale collocazione cronologica, è poi interessante notare come – nell’assenza di testimoni visivi – la bibliografia novecentesca cui si è già fatto riferimento si sia proposta di rintracciare almeno qualche riflesso grafico per un modello tanto lodato, rimeditando un’indicazione di Battelli risalente al 1929.117 Tale operazione mirava cioè a individuare un’icona efficace che di quella maquette potesse simbolizzare ambizioni e intenti, ragioni e obiettivi, in corpo a un’articolata letteratura (e in contrasto con il medesimo suggerimento di partenza). Il Battelli, infatti, aveva riconosciuto in un’opera del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi118 (Fig. 8) – fino ad allora collegato alle tombe sansovinesche in Santa Maria del Popolo a Roma119 – il progetto per un sepolcro richiesto allo scultore da D. João II al fine di commemorare il giovane principe Afonso morto nel 1491; commissione, questa, di cui però non si hanno notizie, né attraverso i documenti contemporanei né grazie alle fonti coeve.
8 Andrea Sansovino (attr.), Progetto per una tomba, penna e acquarello, 589 x 462 mm. Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie degli Uffizi, Firenze, inv. 142 A (foto: Gabinetto fotografico delle Gallerie degli Uffizi – PMF)
[62] Nel commentare l’opera, che raffigura il fronte di un monumento sepolcrale a parete, lo studioso era certo stato indirizzato a sottoscriverne la paternità sansovinesca dalla presenza dell’iscrizione antica recitante "Andrea Contucci dal Monte Sansovino scult:"; una nota manoscritta che coincide – per grafia, abbreviazioni e posizione – con altre simili presenti sulle carte già incluse nel Libro de’ disegni del Vasari (di cui anche questo foglio doveva dunque far parte, come sostenuto da Licia Collobi Ragghianti).120
[63] Ripensando nel 1936 un’ipotesi siffatta, Middeldorf avrebbe preferito spostarne la cronologia verso una data più tarda, collocando la sua esecuzione all’inizio del Cinquecento: la "spiritosa, corrente grafia" gli suggeriva infatti di vedervi un’originale di Jacopo Sansovino. Nonostante il disaccordo con l’idea del Battelli (e con la stessa annotazione vasariana), lo studioso rimaneva comunque affezionato a una possibile destinazione portoghese: collegava infatti l’opera al passaggio delle Vite dedicato al modello eseguito dal Tatti per la "tomba" di un re lusitano.121
[64] L’autorevolezza di tale contributo ha fatto sì che si continuasse ad associare al disegno una funzione analoga, quella cioè di una rara traccia del coinvolgimento dei Sansovino nel mecenatismo degli Avis; e sebbene sia stato di volta in volta ritenuto un autografo di Andrea o di Jacopo, raramente si è arrivati a metterne in dubbio la natura di pensiero per il mausoleo di un monarca portoghese, usata anche solo come utile etichetta per segnalare il foglio nella produzione grafica dei due artisti.122 In questo senso si sono espressi la Garrard,123 propensa ad avvicinarlo al catalogo del Tatti, Moreira124 e Höfler,125 che lo hanno invece creduto di mano del maestro più anziano. In ultimo, Fattorini si è sentito di sottoscrivere l’attribuzione al Tatti sulla scorta del giudizio di Middeldorf, accogliendo però le osservazioni di Höfler relative alla presenza dei santi onomastici di D. João II (l’Evangelista e "un probabile Battista") nella fascia superiore dei pilastri laterali; ragion per cui il disegno andrebbe, secondo la sua opinione, identificato come il progetto per un monumento funerario al Principe Perfetto.126
[65] In questa pur generosa bibliografia, non ci si è tuttavia mai interrogati su quale funzione il foglio potesse avere, alla luce della sua fattura, della qualità del tratto e del formato della carta. Non ci troviamo, infatti, con tutta evidenza, difronte a uno schizzo o alla registrazione tachigrafica di un primo pensiero; né si può ritenerlo il testimonio di uno studio di bottega, condotto rapidamente fra le molte attività di un fondaco. Sconsiglia una simile interpretazione la quasi totale assenza di varianti o ripensamenti, correzioni o sviste, imprecisioni e modifiche. Al contrario la costruzione simmetrica dell’immagine, il ricorso accurato alla penna e all’acquarello, la resa prospettica calibrata nella traduzione di luci e ombre, utili a rendicontare aggetti o profondità, la minuziosa restituzione dei dettagli figurativi, dalle statue ai rilievi, ne fanno un probabile disegno di presentazione, un prodotto cioè inteso per venire sottoposto all’esame del committente nella fase di valutazione di un’impresa monumentale.
[66] Le stesse dimensioni suggerirebbero un simile impiego. Il supporto su cui è tracciato il disegno è composto infatti dall’unione di due fogli che insieme raggiungono la misura di 590 x 463 mm, altezza e larghezza quasi perfettamente coincidenti con quelle di un reale, uno dei tagli commerciali diffusi nel mercato della carta in epoca medievale e moderna. Sembrerebbe dunque che il progetto venisse organizzato secondo uno schema razionale, calibrandone la composizione sul supporto soggiacente, preparato a monte del lavoro di scrittura nel rispetto di uno dei formati di maggior respiro per il campionario commerciale del tempo. In quest’ottica si giustifica anche la qualità discontinua del foglio, il quale associa un trattamento più diligente dell’architettura d’insieme a una vivace resa delle figure e degli elementi di ornato. Pensando infatti a una creazione impegnativa, intesa per realizzare un prodotto in tutto finito e destinato a venir sottoposto al giudizio di un committente, si potrebbe supporre l’intervento di mani distinte, secondo una meticolosa suddivisione degli impegni, favorevole a una verifica continuativa del lavoro. Non sembrerebbe infatti irrealistico che sull’impaginatura tracciata da un esecutore meno sprezzato, servendosi di una griglia rigida e preventivamente concordata, operasse poi un maestro di maggiore esperienza, responsabile della delicata, libera aggiunta della decorazione scultorea.
[67] Tale proposta rende ancora più difficile accogliere le ipotesi fin qui sottoscritte in bibliografia, ad eccezione del parere espresso da George Haydn Huntley127 e da Boucher128 (seguiti da Grilo)129, i quali non hanno condiviso l’identificazione del disegno con il piano per la tomba di un sovrano portoghese. Nel contesto della finalità qui attribuita al foglio, risulterebbe infatti quanto mai difficile spiegare l’assenza di qualsivoglia regalia, circostanza messa in luce dalla Garrard (la quale però non si esprimeva sulla funzione dell’opera in termini di committenza);130 così come assai ardua da accettare si dimostrerebbe la radicale difformità del mausoleo nei confronti della tradizione dei sepolcri delle monarchie europee.
[68] Non solo, infatti, secondo quanto abbiamo sottolineato, il foglio degli Uffizi propone una soluzione a parete, laddove ogni indizio lascia immaginare come le tombe di D. João II e di D. Manuel I – qualora realizzate – fossero piuttosto intese per una pianta indipendente, libera nello spazio (soluzione preferita anche dalle scelte mecenatesche, coeve o appena successive, dei sovrani francesi e spagnoli); la stessa effigie del defunto risulta del tutto anomala nel contesto lusitano così come in quello continentale. La figura, concentrata nella lettura, non si presenta in atto devoto o in apparato guerresco (differentemente da quanto succede, ad esempio, per D. João I nella Capela do Fundador a Batalha);131non si riconoscono, inoltre, tra le sue mani o attorno al sepolcro, attributi come la corona, il bastone del comando, la spada, gli indizi della consacrazione, le decorazioni di ordini cavallereschi o gli animali araldici. Pur nella varietà di una casistica europea, tutti i mausolei regali realizzati fra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, in Portogallo così come in Francia o in Spagna, combinano almeno alcuni fra questi elementi, in una rete di significati differenziata da caso a caso, sempre rispondente alle tradizioni nazionali e tuttavia tesa coerentemente a sottolineare lo statuto eccezionale di ciascun defunto. Succede, ad esempio, nella già citata tomba di D. João I a Batalha che la corona sia unita al bastone di comando (Fig. 9); ma si possono menzionare la sepoltura di Charles VIII a Saint-Denis, immaginata da Mazzoni nel 1499–1500 (Fig. 10), e quella, più tarda, di Louis XII, progettata per lo stesso luogo attorno al 1516 dai Giusti (Fig. 11): entrambi i mausolei associano alle effigi dei sovrani regalia diverse (ad esempio, comune ai due sepolcri è il manto, orlato d’ermellino, legato alla cerimonia d’incoronazione a Reims), evidenziandone comunque l’appartenenza al pantheon dinastico francese.132
9 Tomba di João I e Filipa de Lencastre, 1434, Mosteiro de Santa Maria da Vitória, Batalha (ripr. da: José Custódio Vieira da Silva e Pedro Redol: The Monastery of Batalha, London 2007, 76)
10 Tomba di Charles VIII a Saint-Denis, disegno colorato ante 1711. Bodleian Libraries, Oxford, Mss. Gough, drawings Gaignières 2, c. 48 (foto: Wikicommons)
11 Antonio e Giovanni Giusti, Tomba di Louis XII e Anne de Bretagne, 1516‑1531, Basilica di Saint-Denis (foto: Wikicommons)
[69] Anche i Re Cattolici, ritratti da Domenico Fancelli per il loro sepolcro nella Capilla Real (messo in opera probabilmente nel 1517), sono qualificati da un sistema complesso di insignia, dalla corona alla spada:133 elementi la cui presenza doveva essere stabilita puntualmente per contratto, a giudicare almeno dall’accordo che lo stesso scultore avrebbe firmato nel dicembre 1518 in vista della realizzazione di un’altra tomba per Granada, quella destinata alla figlia di Isabel e Fernando, Juana, insieme al consorte, Philippe le Beau (Fig. 12).134
12 Domenico Fancelli, Tomba di Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, 1514–1517, Capilla Real, Granada (ripr. da: El libro de la Capilla Real, ed. José Manuel Pita Andrade, Granada 1994, 71)
[70] Un caso in parte diverso riguarda l’Inghilterra, almeno in riferimento al sepolcro per Henry VII ed Elizabeth of York, eretto nella Lady Chapel di Westminster Abbey fra 1512 e 1517 su disegno di Pietro Torrigiani (Fig. 13).
13 Pietro Torrigiani, Tomba di Henry VII ed Elizabeth of York, 1512–1517, Westminster Abbey, Londra (foto: Wikicommons)
I due gisants, raggelati in un atto di preghiera e "dressed plainly in royal robes", sono caratterizzati infatti da una medesima povertà di attributi.135 Tuttavia, in questo caso, l’assenza di regalia appare controbilanciata dall’evidenza insolita conferita agli elementi araldici, disposti su entrambi i livelli della cassa sepolcrale in corrispondenza con il fronte est del monumento. Gli scudi innalzati sul sarcofago – uno inquartato e un’arme d’alleanza – assommano infatti alle specifiche genealogiche la presenza della giarrettiera (la decorazione dell’ordine cavalleresco legato alla monarchia anglosassone) e di una corona chiusa; è inoltre opportuno ricordare come un’altra arme, rimossa nel XVII secolo, fosse montata sul fronte ovest, sempre sostenuta da una coppia di putti.136 Proprio le figure reggi-scudo poste ai quattro angoli della cassa impugnavano del resto, fino alla metà del Seicento, quattro insignia legate alla dinastia Tudor (l’insegna del sovrano gallese Cadwallader, insieme alla spada di giustizia, la bilancia e lo stendardo della casa);137 inoltre la divisa familiare della rosa è ripetuta nel fregio di coronamento e in quello sulla base della cassa, nella forma di un pattern decorativo.138
[71] Nel disegno degli Uffizi (Fig. 8) mancano analoghe specifiche dinastiche o araldiche, in una struttura che – pur presentando campi bianchi (il fregio apicale; la tabella epigrafica sul fronte del sarcofago) – non lascia spazio per l’aggiunta di elementi consimili, almeno non in posizione centrale e preminente. Lo stesso globo crucigero, letto da alcuni come un riferimento allo statuto regale del defunto,139 non sembra in questo senso un elemento inequivoco. Si deve infatti evidenziare che, nel rapporto assiale costruito fra le figure incluse nel mausoleo, un simile dettaglio – distanziato dal gisant – è invece sovrapposto al tondo con la Vergine e il Bambino (e collocato al di sotto della formella con il Cristo morto, sebbene nel rispetto di un cospicuo intervallo spaziale): lo si potrebbe dunque leggere come un simbolo da relazionarsi al dominio ultramondano del Cristo, piuttosto che a una qualche potestà regale del defunto. La circostanza non stupisce: per esempio, in entrambe le tombe approntate fra 1505 e 1509 in Santa Maria del Popolo a Roma da Andrea – una per il cardinal Girolamo Basso della Rovere e una per Ascanio Sforza – le statue apicali dell’Eterno reggono, nella sinistra, un globo (Fig. 14). Non solo. Sebbene infatti l’insegna sia presente – in epoca moderna – fra le regalia delle corone europee (è il caso, fra le altre, di quella inglese),140 essa non compare – a cavallo del Quattro e del Cinquecento – nei monumenti sepolcrali delle stesse monarchie continentali: fa eccezione la sola tradizione germanica, l’unica cioè direttamente legata alla discendenza imperiale, come dimostra il gisant fiammante di Frederick III nello Stephansdom di Vienna, opera di Nikolaus Gerhaert da Leida (avviata nel 1469, ma conclusa nel 1513) (Fig. 15).141
14 Andrea Sansovino, Tomba di Ascanio Sforza, 1505–1509, Santa Maria del Popolo, Roma (foto: proprietà dell’autore)
15 Nikolaus Gerhaert da Leida e Michael Tichter, Tomba di Friedrich III, 1469–1513, Stephansdom, Vienna (ripr. da: Niclaus Gerhaert: Der Bildhauer des Späten Mittelalters, cat. mostra, ed. Stefan Roller, Francoforte 2012)
[72] Significativamente nell’opinione di Moreira il riconoscimento del progetto con quello per una tomba regia portoghese si baserebbe soprattutto sull’identificazione delle figure inserite nei pilastri laterali. Secondo lo studioso, infatti, la presenza nel registro superiore di un Giovanni Evangelista e di un Battista alluderebbe – attraverso i santi onomastici – all’eventuale dedicazione del mausoleo a D. João II.142 Questa circostanza gli ha suggerito di segnalarvi un’opera del Tatti, parte della progettazione di una tomba per il "Re di Portogallo" e derivativa rispetto a un precedente pensiero di Andrea. In realtà, se l’Apostolo è chiaramente individuabile nella silhouette sulla sinistra (lo denunciano l’Aquila e il rilievo soggiacente, leggibile come una Rivelazione a Patmos), più dubbia rimane l’analisi iconografica del personaggio posto a pendant sulla destra (Fig. 16).
16 Andrea Sansovino (attr.), Progetto per una tomba, dettaglio del santo in alto a destra, penna e acquarello, 589 x 462 mm. Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie degli Uffizi, Firenze, inv. 142 A (foto: Gabinetto fotografico delle Gallerie degli Uffizi – PMF)
[73] Il Battelli, non a caso, lo credeva un San Tommaso, legato – nel rilievo sottostante – all’"episodio dell’incredulità vinta col toccare le piaghe del Signore"; la Garrard, invece, lo riteneva un San Giacomo (senza però escludere del tutto l’ipotesi di potervi vedere un Battista).143 Del resto la figura non veste il vello tradizionalmente associato al cugino di Cristo e stringe nella mano un attributo che, pur nella difficoltà di lettura (forse un libro di taglio), si distingue da una croce astile, simbolo corrente per le immagini del San Giovanni. Gli unici santi inclusi con certezza nella struttura della tomba devono quindi essere considerati: un Giovanni Evangelista, un Pietro e un Paolo (a loro volta chiaramente identificabili per le chiavi e la spada).
[74] Contestata questa traccia indiziaria, ci pare che non si possa mantenere il legame del foglio con un eventuale mausoleo per un re portoghese;144 e prova ulteriore della sua estraneità alla committenza manuelina può forse trovarsi nel confronto con i due sepolcri richiesti attorno al 1518 per il monastero di Santa Cruz a Coimbra (Fig. 7). Afonso Henriques e Sancho I, i primi due reggenti della monarchia lusitana, vi sono infatti raffigurati – pur dentro una struttura ad arcosolio – come re-guerrieri, l’animale araldico ai piedi, i gisants immersi in un’orazione eterna. Entrambi i sepolcri, nella lunetta di coronamento, sono poi decorati col ricorso a un doppio tondo, vistosissimo, contenente la croce dell’Ordine del Cristo, un ordine militare stabilito nel 1319 da Giovanni XXII su richiesta del sovrano portoghese D. Dinis, per il quale D. Manuel aveva reclamato speciali privilegi proprio nel corso dell’ambasciata romana del 1514.145
[75] Vista la coerenza del programma dinastico agito dall’Avis nell’ultima parte del regno, sembra difficile che la dissonanza fra quanto realizzato nella seconda metà degli anni Dieci e il progetto per la propria tomba (o per quella del suo predecessore) potesse essere a tal punto stridente. Del resto, se si crede il foglio degli Uffizi un disegno di presentazione, come tutto lascia ipotizzare, bisogna anche considerarlo il risultato di un accordo previo fra artista e committenza, frutto cioè di una trattativa di massima, antecedente alla proiezione grafica del progetto; o, nel caso lo si ritenesse una proposta proveniente dall’Italia per lusingare le ambizioni mecenatesche del re portoghese, non si può supporre che tale invio non fosse preceduto da un qualche sondaggio, volto a chiarire le effettive priorità e preferenze del monarca, secondo una dinamica che è stata ad esempio evidenziata nel caso del modello di Bandinelli, inviato al re d’Inghilterra per volontà di Leone X.146
Il pantheon degli Avis in Santa Maria di Belém nella seconda metà del Cinquecento
[76] Come che sia, le spoglie dell’Avis non trovarono in morte la sepoltura che il sovrano aveva per sé previsto nel complesso gerolamino di Santa Maria di Belém. Al momento del decesso il 13 dicembre 1521, i lavori sul monastero erano infatti lungi dall’essere terminati. È dunque possibile che, anche a causa di simili lungaggini, la pianificazione del mausoleo passasse in secondo piano, tanto più che la corona lusitana – sul finale degli anni Dieci – si trovò a vivere una situazione politica meno brillante in una prospettiva internazionale. In ragione di ritardi siffatti, fu pertanto necessario ricoverare il corpo di D. Manuel nella chiesa vecchia del Restelo, dove venne interrato nel corso di una fastosa cerimonia funebre. Solo nel 1551 – per volontà del figlio ed erede, D. João III – la sua salma (assieme a quelle della consorte, Maria de Aragão, e dei due figli, Afonso e Manuel) fu traslata nel luogo designato per la tomba dal testamento del 1517, quando l’erezione dell’edificio era stata finalmente portata a compimento. Tuttavia, anche in quest’occasione nessun sepolcro fu eretto alla sua memoria. Nello stesso anno, la decorazione della capela-mor si vide infatti affidata all’architetto Diogo de Torralva, venendo però terminata per assolvere alla funzione di pantheon dinastico ben dopo la scomparsa di D. João III, avvenuta nel 1557. L’ambiente fu cioè inaugurato nel 1572, quando ormai da tempo la direzione del cantiere era stata delegata a Jerónimo de Ruão.147
[77] Il brillante dialogo intrattenuto dalla corona portoghese con la realtà italiana e con gli scultori fiorentini nel primo quarto del secolo si vedeva così 'tradito' per scelte che si rivolgevano invece a un ambiente artistico locale, trasformato nel peso delle singole maestranze e nelle ambizioni intellettuali nutrite dalle singole personalità in esso coinvolte. Del resto, l’intera storia continentale – e in particolare quella della penisola iberica – aveva intrapreso un cammino diverso dal percorso che ne aveva segnato le vicende all’alba del secolo, vedendo radicalmente modificate le dinamiche culturali attive in ciascun paese e le esigenze connesse alla politica di immagine delle monarchie europee.
Acknowledgements Vorrei ringraziare Denise Allen, Dario Donetti, Giancarlo Gentilini, Alessandro Nova, Maria José Redondo Cantera, Samuel Vitali.
Reviewers Anonimi
Local Editor Susanne Kubersky-Piredda, Bibliotheca Hertziana – Max Planck Institute for Art History, Rome
License
The text of this article is provided under the terms of the Creative
Commons License CC-BY-NC-ND 4.0
1 Erwin Panofsky, Tomb Sculpture: Four Lectures on Its Changing Aspects from Ancient Egypt to Bernini, London 1964, 9.
2 Si veda Kathleen Cohen, Metamorphosis of a Death Symbol: The Transi Tomb in the Late Middle Ages and the Renaissance, Berkeley/ Los Angeles/ London 1973.
3 Panofsky, Tomb Sculpture, 67.
4 Si veda Alberto Tenenti, Il senso della morte e l’amore della vita nel Rinascimento, Torino 1989.
5 Per la raccolta di un’ampia casistica, limitata però alla realtà italiana, si veda anche Giulio Ferrari, La tomba nell’arte italiana dal periodo preromano all’odierno, Milano 1917.
6 Ralph E. Giesey, Le Roi ne meurt jamais: les obsèques royales dans la France de la Renaissance, Paris 1987. Si veda anche Giovanni Ricci, Il principe e la morte: corpo, cuore, effigie nel Rinascimento, Bologna 1998.
7 Si veda ad esempio Pedro de Madrazo, "Mausoleo de los Reyes Católicos Don Fernando y Dona Isabel en la Capilla Real de Granada obra de Bartolomé Ordóñez", in: Museo español de antigüedades 1 (1872), 431-447.
8 Carl Justi, "Bartolomé Ordóñez und Domenico Fancelli", in: Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen 12 (1891), 66-90, qui 80-89.
9 Giuseppe Campori, Memorie biografiche degli scultori, architetti, pittori ec. nativi di Carrara e di altri luoghi della provincia di Massa, con cenni relativi agli artisti italiani ed esteri che in essa dimorarono ed operarono, Modena 1873, 269.
10 Anatole de Montaiglon, "La famille des Juste en Italie et en France", in: Gazette des Beaux-Arts 12 (1875), 385-404, 515-525, e in: Gazette des Beaux-Arts 13 (1876), 552-568, 657-670; Gaetano Milanesi, "La famille des Juste. Nouveaux documents", in: Gazette des Beaux-Arts 14 (1876), 360-368.
11 Si veda in ultimo Flaminia Bardati e Tommaso Mozzati, "Jérôme Pacherot et Antoine Juste: artistes italiens à la cour de France", in: Studiolo 9 (2012), 208-254, 363-364, qui 221-226.
12 Marco Pellegrini, Le guerre d’Italia. 1494–1559, Bologna 2009, 153-155.
13 Sui tre letterati si vedano, rispettivamente, Paul Gwynne, Poets and Princes: The Panegyric Poetry of Johannes Michael Nagonius, Turnhout 2012; Godelieve Tournoy-Thoen, "Fausto Andrelini et la cour de France", in: L’Humanisme français au début de la Renaissance, Paris 1973 (= De Pétrarque à Descartes, 29), 65-79; Salvatore Statello, "Cataldo Siculo Parisio. Un umanista alla corte portoghese del tardo Quattrocento", in: Bruniana & Campanelliana 18 (2012), n. 1, 279-288.
14 Timothy Verdon, The Art of Guido Mazzoni, New York 1978 (= tesi di dottorato, Yale University, 1975), 123-134, 338-340. Vedi anche Timothy Verdon, "Guido Mazzoni in Francia: nuovi contributi", in: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 34 (1990), n. 1/2, 139-164, qui 141, 154, 159.
15 Si vedano qui note 9 e 10.
16 Leonardo Cappelletti, Bartolomeo Berrecci da Pontassieve. Un genio del Rinascimento tra arte e filosofia, Firenze 2011; Barbara Arciszewska, "Architectural Crossroads: Migration of Architects and Building Trade Professionals in Early Modern Poland 1500–1700", in: Architects Without Borders. Migration of Architectural Ideas in Europe. 1400–1700, ed. Konrad Ottenheym, Mantova 2014, 61-75.
17 Francesco Caglioti, "Benedetto da Rovezzano in England: New Light on the Cardinal Wolsey-Henry VIII Tomb", in: The Anglo-Florentine Renaissance: Art for the Early Tudors, ed. Cinzia Sicca e Louis A. Waldman, New Haven 2012 (= Studies in British Art, 22), 177-202.
18 Michela Zurla, "Domenico Fancelli, i re di Spagna e la congiuntura carrarese", in: Norma e capriccio: spagnoli in Italia agli esordi della "maniera moderna", cat. mostra, ed. Tommaso Mozzati e Antonio Natali, Firenze 2013, 132-145.
19 Tommaso Mozzati, "Patres patris patriae: le tombeau des Ducs d’Orléans à Saint-Denis", in: La France et l’Europe autour de 1500: croisements et échanges artistiques, atti del convegno (Parigi, 9-11 dicembre 2010), ed. Geneviève Bresc-Bautier, Thierry Crépin-Leblond ed Élisabeth Taburet-Delahaye, Paris 2015 (= XXVIIes Rencontres de l’École du Louvre), 23-38.
20 Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, ed. Rosanna Bettarini e Paola Barocchi, 6 voll., Firenze 1966–1987, IV, 1976, 275.
21 Janez Höfler, "New Light on Andrea Sansovino’s Journey to Portugal", in: The Burlington Magazine 134 (1992), n. 1069, 234-238, qui 235-236, 238 appendix.
22 Rafael Moreira, A Arquitectura do Renascimento no Sul de Portugal. A encomenda Régia entre o moderno e o romano, tesi di dottorato (inedita), Universidade Nova de Lisboa, 1991, 2 voll., I, 74, note 111-112, II, 3-14.
23 Höfler, "New Light", 236; Fernando-Jorge Grilo, "Andrea Sansovino e Nicolau Chanterene. As duas faces da introdução do Renascimento em Portugal", in: A Arte na Península Ibérica ao tempo do tratado de Tordesilhas, atti del convegno (Coimbra, 8-10 settembre 1994), ed. Pedro Dias, Coimbra 1998, 263-328, qui 281-282, nota 45.
24 Vasari, Le vite, IV, 1976, 127, V, 1984, 108.
25 Si veda Nunziatella Alessandrini, "La presenza italiana a Lisbona nella prima metà del Cinquecento", in: Archivio storico italiano 164 (2006), n. 1, 37-54, qui 42-43. Si vedano anche Federigo Melis, "Di alcune figure di operatori economici fiorentini attivi nel Portogallo nel XV secolo", in: I mercanti italiani nell’Europa medievale e rinascimentale, ed. Luciana Frangioni, Firenze 1990, 1-18; Marcello Berti, "Le aziende da Colle: una finestra sulle relazioni commerciali tra la Toscana ed il Portogallo a metà del Quattrocento", in: Toscana e Portogallo. Miscellanea storica nel 650° anniversario dello Studio Generale di Pisa, Pisa 1994, 57-105; Paulino Iradiel Murugarren e David Igual Luis, "Del Mediterráneo al Atlántico. Mercaderes, productos y empresas italianas entre Valencia y Portugal (1450–1520)", in: Portogallo mediterraneo, ed. Luís Adão da Fonseca e Maria Eugenia Cadeddu, Cagliari 2001, 143-194. Per uno sguardo più generale sul tema in epoca moderna, si vedano Carmen M. Radulet (ed.), Case commerciali, banchieri e mercanti italiani in Portogallo, atti del convegno (Lisbona, 3-5 settembre 1998), Lisbona 1998; Maria Elisa Soldani, "Dal Mediterraneo all’Atlantico. Gli uomini d’affari fiorentini nella penisola iberica fra Tre e Quattrocento", in: Vespucci, Firenze e le Americhe, atti del convegno (Firenze, 22-24 novembre 2012), ed. Giuliano Pinto, Leonardo Rombai e Claudia Tripodi, Firenze 2014 (= Biblioteca storica toscana, 71), 43-62.
26 Rafael Moreira, "Andrea Sansovino au Portugal (1492–1501)", in: Revue de l’art 133 (2001), 33-38, qui 35. Su questo argomento si veda anche Dorothee Heim, "Spurensuche in Spanien: Andrea Sansovino und das Rätsel seiner Werke in Toledo", in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 69 (2006), 489-507, qui 493.
27 Sul valore di terminus ante quem rivestito da questa notizia rispetto al rientro di Andrea in Italia, si veda Gabriele Fattorini, Andrea Sansovino, Trento 2013, 45-46, 58-60, 168-169, cat. 5. Per il documento si veda Rolf Bagemihl, "Cosini’s Bust of Raffaello Maffei and Its Funerary Context", in: Metropolitan Museum Journal 31 (1996), 41-57, qui 57, nota 53.
28 Sia nell’edizione Torrentiniana (1550) sia nella Giuntina (1568), Vasari propone il "MD" come data per questo rientro; si veda Vasari, Le vite, IV, 1976, 275. Su questa cronologia si veda Heim, "Spurensuche in Spanien", 493, che anticipa, rispetto al rientro in patria, una sosta toledana; si veda poi Fattorini, Andrea Sansovino, 58.
29 Manfredo Tafuri, Venezia e il Rinascimento: religione, scienza, architettura, Torino 1985, 166, nota 35; Moreira, "Andrea Sansovino au Portugal", 34-35; Rafael Moreira, "Andrea Sansovino em Lisboa (1492–1501): entre a Batalha e Toledo, e de Benavente a Azeitão e Sintra", in: Revista de estudos italianos em Portugal 12 (2017), 111-130, qui 126-127. Si veda anche Fattorini, Andrea Sansovino, 43-45.
30 Vasari, Le vite, IV, 1976, 275.
31 Vasari, Le vite, IV, 1976, 273-274. Sull’antisagrestia si veda Fattorini, Andrea Sansovino, 30-31.
32 Höfler, "New Light", 235-236.
33 Giovanni Gaetano Bottari, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed architettura scritte da’ più celebri Professori che in dette Arti fiorirono dal Secolo XV al XVII, 7 voll., Roma 1754–1773, III, 1759, 333-334, n. CCV; Giovanni Gaetano Bottari, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed architettura […] continuata fino ai nostri giorni da Stefano Ticozzi, 8 voll., Milano 1822–1825, III, 1822, 492-493, n. CCV. Si opta qui per la trascrizione rivista da Giulia Cerquozzi, Michela Corso e Maria Rosa Pizzoni, in: Notizie di pittura raccolte dal padre Resta. Il carteggio con Giuseppe Ghezzi e altri corrispondenti, ed. Maria Rosa Pizzoni, Roma 2018, pp. 159-160, n. 15. Sull’epistolario fra Resta e Ghezzi, si veda Maria Rosa Pizzoni, "Il carteggio tra Sebastiano Resta e Giuseppe Ghezzi: uno sguardo sull’arte nella Roma moderna", in: Notizie di pittura, 39-81.
34 Sul disegno si vedano in ultimo Maria Rosa Pizzoni, "Trascrizione e commento", in: Le postille di padre Sebastiano Resta ai due esemplari delle Vite di Giorgio Vasari nella Biblioteca Apostolica Vaticana, ed. Barbara Agosti e Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, Città del Vaticano 2015, 104-105, nota 184; Francesco Grisolia, Trattenimenti pittorici. I disegni del Codice Resta degli Uffizi, Roma 2018, 115-117, cat. 33, qui 117, che lo identificano in via ipotetica con il foglio del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie degli Uffizi, inv. 142 A; nel caso tale riconoscimento fosse provato, bisognerebbe pensare che il Resta interpretasse il disegno come il progetto di un sepolcro regio, sebbene tale lettura non ci sembri condivisibile; si veda più avanti nel corpo dell’articolo.
35 Höfler, "New Light", 236. Andrew Butterfield sostiene che, più tardi dopo il suo arrivo in Portogallo, Andrea avrebbe disegnato una tomba per D. João II; si veda Andrew Butterfield, "A Virgin and Child attributed to Andrea Sansovino", in: The Burlington Magazine 152 (2010), n. 1292, 723-726, qui 726. Nello stesso contributo lo studioso considera perduto il disegno già Resta.
36 "Testamento de el-rei D. João II. Alcáçovas, 1495, Setembro, 29", in: As Gavetas da Torre do Tombo 6 (1967), 88-98, n. 3784, qui 89. Tutte le traduzioni dal portoghese sono di chi scrive.
37 Nel 1416 D. João I fece trasportare a Batalha le ossa della moglie Filipa de Lencastre dal monastero cistercense de São Dinis e São Bernardo di Odivelas (dove era morta di peste), a dimostrazione di come avesse probabilmente già maturato l’intenzione di trasformare la chiesa in un pantheon dinastico; le spoglie della regina furono in un primo momento deposte nella cappella maggiore; Maria Helena Coelho da Cruz, "D. João I", in: História dos Reis de Portugal. Da Fundação à perda da independência, ed. Manuela Mendona, 2 voll., Lisbona 2010–2011, I, 2010, 476-492, qui 484. Nel 1426, il testamento del sovrano – redatto il 4 ottobre – formalizzava tale volontà (Saul António Gomes, Fontes históricas e artísticas do Mosteiro e da Vila da Batalha. Séculos XIV a XVII, 2 voll., Lisbona 2002, I, 134-135, doc. 52); si vedano anche Saul António Gomes, O Mosteiro de Santa Maria da Vitória no século XV, Lisbona 1990, 3-10, 19, 253-261, 341-367; Saul António Gomes, "Percursos em torno do Panteão quatrocentista de Avis", in: Biblos 70 (1994), 197-242, qui 205-221; Maria João Baptista Neto, "La expresión condicionada por la Historia. Panteones dinásticos portugueses: de las concepciones iniciales a las restauraciones contemporáneas", in: Grabkunst und Sepulkralkultur in Spanien und Portugal. Arte funerario y cultura sepulcral en España y Portugal, ed. Barbara Borngässer, Henrik Karge e Bruno Klein, Francoforte sul Meno 2006 (= Ars Iberica et Americana, 11), 359-375, qui 360-363.
38 Poemata Cataldi, Lisbona [1501–1502], s. c. [ma cc. 104v-105r].
39 "Chronica d’el rey D. Joaõ II, por Ruy de Pina", in: Collecção de livros ineditos de historia portugueza dos reinados de D. Joaõ I, D. Duarte, D. Affonso V, e D. Joaõ II publicados de ordem da Academia real das sciencias de Lisboa, ed. José Corrêa da Serra, 5 voll., Lisbona 1790–1824, II, 1792, 5-212, qui 198-199 (cap. LXXXIII).
40 È significativo che, nelle sue note alle Vite del Vasari, Sebastiano Resta attribuisca alla responsabilità di D. Manuel l’erezione di un sepolcro per D. João II: "Io tengo il sepolcro di Gio[vanni] II fatto di m[an]o sua doppo morte, quale seguì del 1495, 14 sett[embr]e e fu sepolto dove morì alli Bagni Alborensi. Intanto Andrea d’ordine d’Emanuele herede li fece il sepolcro nella chiesa di Battaglia lontana da Lisbona 24 leghe, e due da Lesia, dove si vedono ancor hoggi i sepolcri dei Re, et in questo novo Magnificentiss[im]o sepolcro di cui io ho il disegno, fu trasferito l’anno 4° doppo la morte cioè del 1499". Chiaramente si tratta di informazioni di seconda mano: Resta dà per realizzata una tomba che in realtà non venne messa in opera, pur menzionando correttamente il luogo di sepoltura delle spoglie del re portoghese; si veda Pizzoni, "Trascrizione e commento", 104-105, nota 184.
41 Si veda Livro das obras de Garcia de Resende, que tracta da vida & grandissimas virtudes & bondades, magnanimo esforço, excelentes costumes & manhas & muy craros feitos do christianissimo el rey dom Ioam ho segundo […], Évora 1554, c. 115r. (cap. CCXIII). Di recente Garcia de Resende, Vida e Feitos d’ El-Rey Dom João Segundo, ed. Evelina Verdelho, Coimbra 2007, 281.
42 Elaine Sanceau, O Reinado do Venturoso, Porto 1970, 7-17; Luís Adão da Fonseca, D. João II, Lisbona 2007 (= Reis de Portugal), 222-241; João Paulo Oliveira e Costa, D. Manuel I (= Reis de Portugal), Lisbona 2011, 106-116.
43 È presente in chiesa, nei pressi dell’abside, una targa commemorativa che ricorda la sepoltura di D. João II; Filipa Gomes do Avellar e Miguel Maria Telles Moniz Côrte-Real, "As inscrições funerárias da Sé. Estudo epigráfico e biográfico dos sepultados", in: Monumentos 23 (2005), 78-99, qui 87, n. 20. Sull’edificio si veda Pedro Dias, A Arquitectura gótica portuguesa, Lisbona 1994 (= Teoria da Arte, 11), 173-174. Si veda più di recente João Vasco Reys, Vozes da Pedra: tumulária e armaria da Sé Velha de Silves, Silves 2002. È interessante notare come, nell’ottobre del 1499, D. Manuel I "[…] mandou reedificar a Sé com obras novas, ficando um grande e sumptuoso templo, o coro foi feito em madeira de cedro que por esse tempo havia na ribeira de Silves"; si veda Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 80 (1955): Sé Catedral de Silves, 24.
44 Ana Isabel Buescu, "Uma sepultura para o rei. Morte e memória na trasladação de D. Manuel I (1551)", in: Lugares de poder: Europa séculos XV a XX, ed. Rita Costa Gomes e Gérard Sabatier, Lisbona 1998, 185-203, qui 185-190; Ana Cristina Araújo, "Cultos da realeza e cerimoniais de estado no tempo de D. Manuel I", in: III Congresso Histórico de Guimarães – D. Manuel e a sua época, 4 voll., Guimarães 2004, IV, 73-94, qui 74-79; Ana Isabel Buescu, "A morte do rei. Tumulização e cerimónias de trasladação dos reais corpos (1499–1582)", in: Ler história 60 (2011), 9-33.
45 Livro das obras, cc. 116v-118v.
46 Oliveira e Costa, D. Manuel I, 133-137.
47 Bardati e Mozzati, "Jérôme Pacherot", 220.
48 Michela Zurla, Domenico Fancelli, scultore da Settignano: l’esportazione del Rinascimento fiorentino nella Spagna dei Re Cattolici, tesi di laurea (inedita), Università degli Studi di Perugia, 2008–2009, 130-131.
49 Catarina Fernandes Barreira, "O Mosteiro de Sta. Maria da Vitória e a vocação moralizante das gárgulas do Panteão Duartino", in: D. Duarte e a sua época. Arte, cultura, poder e espiritualidade, ed. Catarina Fernandes Barreira e Miguel Metelo de Seixas, Lisbona 2014, 185-210, qui 194-195.
50 Gomes, Fontes históricas, I, 204.
51 Si vedano Albrecht Haupt, A Arquitectura do Renascimento em Portugal, Lisbona 1986, 157-168; Ralf Gottschlich, "Das Kloster Batalha als Grablege der portugiesischen Könige aus dem Haus Avíz", in: Grabkunst und Sepulkralkultur in Spanien und Portugal, ed. Borngässer, Karge e Klein, 339-357.
52 Alan Phipps Darr, Pietro Torrigiano and his Sculpture for the Henry VII Chapel, Westminster Abbey, 3 voll., Ph.D. Diss., New York University, 1980, 110-135; si vedano anche Thomas Cocke, "The Repository of Our English Kings: the Henry VII Chapel as Royal Mausoleum", in: Architectural History 44 (2001), 212-220; Westminster Abbey: the Lady Chapel of Henry VII, ed. Tim Tatton-Brown, Woodbridge 2003; Phillip Lindley, "Henry’s VII Chapel, Westminster Abbey", in: Making Medieval Art, ed. Phillip Lindley, Donington 2003, 202-211.
53 W. P. Martens, La Rotonde des Valois à Saint-Denis, Bruxelles 1988; Geneviève Bresc-Bautier, "Le monument funéraire de Henri II et les sculptures de la chapelle des Valois à Saint-Denis", in: Primatice, maître de Fontainebleau, cat. mostra, ed. Dominique Cordellier, Bernadette Py e Laura Aldovini, Paris 2004, 426-428; Christoph Luitpold Frommel, "La Rotonda dei Valois e le sue radici", in: Francesco Primaticcio architetto, ed. Sabine Frommel, Milano 2005, 214-227.
54 Si veda Felipe Pereda, "Entre Portugal y Castilla: la secuencia formal de las capillas ochavadas de cabecera en el siglo XV", in: Demeures d’éternité. Églises et chapelles funéraires aux XVe et XVIe siècles, atti del convegno (Tours, 11-14 giugno 1996), ed. Jean Guillaume, Paris 2005, 49-64. Sul ricorso a modelli spagnoli per la cappella di D. Duarte I, si veda Vergílio Correia, Batalha. Estudo Histórico-Artístico-Arqueológico do Mosteiro da Batalha, 2 voll., Porto 1929, I, 49-54; Dias, A Arquitectura gótica, 126.
55 Françoise Robin, "Les chapelles seigneuriales et royales françaises au temps de Louis XI", in: La France de la fin du XVe siècle: renouveau et apogée, atti del convegno (Tours, 3-6 ottobre 1983), ed. Bernard Chevalier e Philippe Contamine, Paris 1985, 237-252; Alain Erlande-Brandenburg, "Les tombes royales et princières françaises aux XIVe et XVe siècles", in: Demeures d’éternité, ed. Guillaume, 9-18.
56 Si veda Gomes, Fontes históricas, II, 391, n. 403. Si vedano anche Correia, Batalha, II, 62; Gomes, O Mosteiro, 100, 103-104; José Custódio Vieira da Silva e Pedro Redol, The Monastery of Batalha, London 2007, 21; Ricardo J. Nunes da Silva, "A obra tardo-gótica do mestre Mateus Fernandes nos finais do século XV e os primeiros anos do século XVI", in: Convergências. Revista de Investigação e Ensino das Artes. Escola Superior de Artes Aplicadas. Instituto Politécnico de Castelo Branco 6 (2010), http://convergencias.esart.ipcb.pt/?p=article&id=86 (accesso 12 maggio 2020). Sulla funzione politica attribuita al cantiere ancora negli anni Ottanta del XV secolo da D. João II, si veda Gomes, "Percursos", 208-209.
57 Gomes, O Mosteiro, 57, 103-105; Vieira da Silva e Redol, The Monastery of Batalha, 21, 107; António Luis Ferreira, O mosteiro de Santa Maria da Vitória no século XVI. As Capelas Imperfeitas e o Renascimento em Portugal, Dissertação, Mestrado em Arte, Património e Teoria do Restauro, Universidade de Lisboa, 2014, http://hdl.handle.net/10451/20394, 44-45; Orlindo Jorge e Pedro Redol, "As Capelas Imperfeitas do Mosteiro da Batalha. Arqueologia e história da sua construção", in: Cadernos de Estudos Leirienses 5 (2015), 301-316, qui 305-309; Pedro Redol e Rita Quina, "The Church", in: Places of Prayer in the Monastery of Batalha, cat. mostra, ed. Pedro Redol e Saul António Gomes, Lisbona 2015, 41-45, qui 41.
58 Gomes, Fontes históricas, II, 444-445, doc. 433.
59 Nunes da Silva, "A obra tardo-gótica". Nel dicembre 1499 Manuel I prese decisioni sulla liturgia dei defunti a Batalha e, nello stesso anno, aumentò la pensione destinata al monastero; si vedano Gomes, Fontes históricas, II, 483-487, doc. 454; Saul António Gomes, "The Mass for the Dead", in: Places of Prayer, 77; Saul António Gomes, "The Founder’s Chapel", in: Places of Prayer, 84.
60 Araújo, "Cultos da realeza", 78, nota 20.
61 Riconoscono nella miniatura una rappresentazione delle seconde esequie di D. João II: Vasco Graça Moura, "Damião de Góis e o Livro de Horas dito de D. Manuel", in: Arte Ibérica 3 (1999), n. 24 (Suplemento), 3-26, qui 3-9; Araújo, "Cultos da realeza", 76, nota 17. Sul dibattito storico relativo a questa miniatura, si veda Dagoberto Markl, Livro de Horas de D. Manuel, Lisbona 1983, 137-142.
62 Livro das obras, c. 118r.
63 Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori scritte da M. Giorgio Vasari pittore et architetto aretino, ed. Karl Frey, Monaco di Baviera 1911, I.1, 347, n. 130. Ritiene che l’annotazione di Frey, desunta dagli Spogli Strozziani, sia degna di fede George Haydn Huntley, Andrea Sansovino, Cambridge, Mass. 1935, 33. Considera con cautela questa notizia Heim, "Spurensuche in Spanien", 493. Non la prendono invece in considerazione la raccolta documentaria curata dalla Baldini (Nicoletta Baldini, Andrea Sansovino. I documenti, Firenze 1999 [= Progetto Sansovino, 1]) o la monografia composta nel 2013 da Fattorini.
64 Höfler, "New Light", 237. Per un’opinione analoga relativa a un soggiorno non continuativo di Sansovino in Portogallo, si vedano Huntley, Andrea Sansovino, 33-35; Peter Murray e Linda Murray, A Dictionary of Art and Artists, London 1968 (= Penguin Reference Books, 14), 372; Silvana Macchioni, "Contucci, Andrea detto il Sansovino", in: Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1960–, XXVIII, 1983, http://www.treccani.it/enciclopedia/contucci-andrea-detto-il-sansovino_(Dizionario-Biografico)/ (accesso 12 maggio 2020); Fernando-Jorge Grilo, "Andrea Sansovino em Portugal no tempo de D. Manuel I", in: Cadernos de História da Arte 1 (1991), 103-134, qui 107-113; Grilo, "Andrea Sansovino e Nicolau Chanterene", 276-307; Fattorini, Andrea Sansovino, 41-43, 51-53. Si sono dimostrate impraticabili le proposte formulate da Manuel C. Mendes Atanázio, "A Vinda de Andrea Sansovino a Portugal", in: A Introdução da arte da Renascença na Península Ibérica, atti del convegno (Coimbra, 26-30 marzo 1980), Coimbra 1981, 189-200, qui 197-200; Manuel C. Mendes Atanázio, A Arte do Manuelino, Lisbona 1984, 29.
65 Höfler, "New Light", 237. Si veda Heim, "Spurensuche in Spanien", 493. Sui soggiorni fiorentini, si veda anche Fattorini, Andrea Sansovino, 51-52, che propende per sottoscrivere – seppure in ipotesi – solo il primo, quello cioè del 1493 (rimanda ai documenti trascritti in Baldini, Andrea Sansovino, 54, n. 28, 55-56, n. 31). Ciro Girolami, Andrea Sansovino, tesi di laurea, Università degli Studi di Firenze, 2 voll., 1935–1936, I, 151-171, 172-214, ipotizzava invece che Andrea fosse rientrato in Toscana nel 1498 sulla base dell’attribuzione a Sansovino della tomba di Fabiano del Monte, nella pieve di Monte San Savino; confuta questa ipotesi Fattorini, Andrea Sansovino, 52-53.
66 Fattorini, Andrea Sansovino, 52, ipotizza che una ragione del rientro potrebbe essere stata la "necessità di disbrigare qualche affare prima di lasciare Firenze per lungo tempo", implicitamente supponendo che Andrea – arrivato per un breve soggiorno – avesse trovato in Portogallo condizioni favorevoli a una permanenza più stabile.
67 Per la ricostruzione di questi spostamenti può essere utile anche l’analisi dei pagamenti della matricola dell’Arte dei maestri di pietra e legname già resi noti da Huntley, Andrea Sansovino, 34-35.
68 Per un’ipotesi recente, si veda Fernandes Barreira, "O Mosteiro", 196-197; Jorge e Redol, "As Capelas Imperfeitas", 315-316.
69 Si veda Maria João Baptista Neto, "O restauro do Mosteiro de Santa Maria da Vitória de 1840 a 1900", in: Cadernos de História da Arte 1 (1991), 219-247; Maria João Baptista Neto, "Elementos para o estudo do Mosteiro de Santa Maria da Vitória no século XIX", in: Lusíada. Revista de ciência e cultura 2 (1992), 219-232; Maria João Baptista Neto, James Murphy e o restauro do mosteiro de Santa Maria da Vitória no século XIX, Lisbona 1997. Sulle tombe concentrate nelle Cappelle Imperfette nel corso del XX secolo, si veda Sérgio Guimarães de Andrade, Santa Maria da Vitória. Batalha, Lisbona/Mafra 1992, 86-87.
70 Correia, Batalha, I, 35-50; Vieira da Silva e Redol, The Monastery, 75-83; Gomes, "The Founder’s Chapel", 79-86.
71 Si vedano Harry A. Tummers, "Early Examples of the dextrarum junctio in Funerary Art", in: Medieval Europe 1992: a Conference on Medieval Archaeology in Europe (University of York, 21–24 settembre 1992), pre-printed papers, vol. 7: Art and Symbolism, York 1992, 203-208; Pedro Dias, História da Arte em Portugal, 14 voll., Lisbona 1986–1988, IV, O Gótico, 1986, 111-138; Gomes, "Percursos", 211-213.
72 Begoña Farré Torras, "Four Princes, One Monument, One Perfect King: The Fifteenth-Century Pantheon of an Idealized Royal Family in the Monastery of Santa Maria da Vitória, Batalha, Portugal", in: Portuguese Studies Review 22 (2014), n. 1, 77-96, qui 82-95; Jessica Barker, "Frustrated Seeing: Scale, Visibility, and a Fifteenth-Century Portuguese Royal Monument", in: Art History 41 (2018), n. 2, 220-245.
73 Nota 70.
74 "Testamento de el-rei D. Manuel I, Mosteiro de Peralonga, 1517, Abril, 7", in: As Gavetas da Torre do Tombo 6 (1967), 111-122, n. 3794, qui 111-112.
75 "Testamento de el-rei D. Manuel I", 119.
76 Paulo Pereira, "Armes divines. La propagande royale, l’architecture manuéline et l’iconologie du pouvoir", in: Revue de l’art 133 (2001), 47-56.
77 José da Felicidade Alves, O Mosteiro dos Jerónimos, 3 voll., Lisbona 1989–1993, I: Descrição e evoção, 1989, 19-21; II: Das origens à actualidade, 1991, 19-33.
78 Felicidade Alves, O Mosteiro dos Jerónimos, I, 19-21, II, 35-46, 52-55, 84-86.
79 Chronica do serenissimo senhor Rei D. Manoel escrita por Damião de Goes e novamente dada a luz […] por Reinerio Bocache, Lisbona 1799, 594 (quarta parte, cap. LXXXIII). Si veda anche Urbis Olisiponis Descriptio per Damianum Goem Equitem Lusitanum, Évora 1554, s. c. Il testamento di D. Manuel, tuttavia, fa riferimento solamente alla propria tomba.
80 Felicidade Alves, O Mosteiro dos Jerónimos, I, 19-21, II, 51-55, 83-84.
81 Felicidade Alves, O Mosteiro dos Jerónimos, I, 24-26, II, 1991, 92-93; Lina Oliveira, "O claustro do Mosteiro de Santa Maria de Belém: da fundação ao século XVIII", in: Mosteiro dos Jerónimos: a intervenção de conservação do claustro, Lisbona 2006, 21-57.
82 Felicidade Alves, O Mosteiro dos Jerónimos, I, 26-29, II, 127-137.
83 Si vedano Pedro Dias, Nicolau Chanterene. Escultor da Renascença, Lisbona 1987, 54-62; Pedro Flor, "Parcours artistiques de Nicolas Chanterenne entre le Gothique tardif et la Renaissance au Portugal", in: La France et l’Europe autour de 1500, 243-253, qui 249-250. Sul valore simbolico della decorazione di Santa Maria di Belém si veda Pereira, "Armes divines", 51-54.
84 Buescu, "A morte do rei", 9-10.
85 Vasari, Le vite, V, 1984, 200-201.
86 Laura Pittoni, Jacopo Sansovino scultore, Venezia 1909, 72-73.
87 Livia Apa, "Guido Battelli e la cultura portoghese", in: L’apporto italiano alla tradizione degli studi ispanici, atti del convegno (Napoli, 30 gennaio - 1° febbraio 1992), Roma 1993, 171-176.
88 Guido Battelli, Il Sansovino in Portogallo, Coimbra 1929, 8-12; Guido Battelli, "Tra i disegni degli Uffizi. Il Mausoleo del Sansovino per il Principe Regale di Portogallo", in: Illustrazione toscana 11 (1933), 8-12; Guido Battelli, Andrea Sansovino e l’arte italiana della Rinascenza in Portogallo, Firenze 1936, 18.
89 Ulrich Middeldorf, "Sull’attività della bottega di Jacopo Sansovino", in: Rivista d’arte 18 (1936), 245-263 (ripubblicato in: Ulrich Middeldorf, Raccolta di Scritti that is Collected Writings, 3 voll., Firenze 1979–1981, I, 1979, 217-228, qui 225-228). Si veda anche Ulrich Middeldorf, "Two Sansovino Drawings", in: The Burlington Magazine 64 (1934), n. 373, 159-164 (ripubblicato in: Middeldorf, Raccolta di Scritti, I, 147-154, qui 152, nota 14).
90 Mary D. Garrard, The Early Sculpture of Jacopo Sansovino: Florence and Rome, Phil. Diss., Johns Hopkins University, Baltimore, MD 1970, 402. Sulla collaborazione del Tribolo, si veda Vasari, Le vite, V, 1984, 201, e più avanti nel testo.
91 Garrard, The Early Sculpture, 410, nota 58.
92 Rafael Moreira, in: XVII Exposição europeia de arte, ciência e cultura. Os descobrimentos portugueses a Europa do Renascimento, Arte antiga I, Lisbona 1983, 318-319, cat. 394. L’idea che lo scultore fosse stato convocato in Portogallo per la realizzazione di un monumento sepolcrale era stata anticipata da Moreira, A Arquitectura, 96; si veda anche Moreira, "Andrea Sansovino em Lisboa", 121.
93 Moreira, "Andrea Sansovino au Portugal", 36, 38, nota 25.
94 Bruce Boucher, The Sculpture of Jacopo Sansovino, 2 voll., New Haven 1991, II, 359, cat. 77.
95 Höfler, "New Light", 237.
96 Grilo, "Andrea Sansovino e Nicolau Chanterene", 263-328, qui 308. Quest’ipotesi non era invece stata accolta in Grilo, "Andrea Sansovino em Portugal".
97 Fattorini, Andrea Sansovino, 48, 50.
98 Alessandra Giannotti, "Pericoli, Niccolò, detto Tribolo", in: Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1960–, LXXXII, 2015, http://www.treccani.it/enciclopedia/pericoli-niccolo-detto-il-tribolo_%28Dizionario-Biografico%29/ (accesso 12 maggio 2020).
99 Boucher, The Sculpture of Jacopo Sansovino, I, 11-23.
100 Vasari, Le vite, V, 1984, 201.
101 Vasari, Le vite, V, 1984, 199-200. Si veda anche Giannotti, "Pericoli, Niccolò".
102 Vasari, Le vite, VI, 1987, 177-178, 180.
103 Si veda qui al paragrafo Andrea Sansovino e le sepolture della corona, fra Batalha e Santa Maria di Belém.
104 Sul Marchionni si vedano Francesco Guidi Bruscoli, "Bartolomeo Marchionni: um mercador-banqueiro florentino em Lisboa (séculos XV–XVI)", in: Le nove son tanto e tante buone, che dir non se pò. Lisboa dos Italianos: História e Arte (sécs. XIV–XVIII), ed. Nunziatella Alessandrini et al., Lisbona 2013, 39-60; Soldani, "Dal Mediterraneo all’Atlantico", 52, 58, 59-61. Grilo, nel sottolineare i possibili legami mecenateschi del Sansovino col Portogallo, ricorda come il Marchionni fosse genero di Francesco Corbinelli; cfr. Grilo, "Andrea Sansovino em Portugal", 114. Allude a un eventuale ruolo del Marchionni anche Moreira, "Andrea Sansovino au Portugal", 34. Sulla comunità degli italiani a Lisbona all’inizio del XVI secolo si veda anche Alessandrini, "La presenza italiana", 37-54.
105 Sanceau, O Reinado, 157-164; Oliveira e Costa, D. Manuel I, 239-240. Si vedano anche Patrice Mac Swiney de Mashanaglass, Le Portugal et le Saint-Siège, I: Les épées d’honneur envoyées par les Papes aux Rois de Portugal au XVIe siècle, Paris 1898, 21-38; Sylvie Deswarte, "Un nouvel âge d’or. La gloire des portugais à Rome sous Jules II et Léon X", in: Humanismo português na época dos descobrimentos, atti del convegno (Coimbra, 9-12 ottobre 1991), Coimbra 1993, 125-152, qui 142-152; Silvio A. Bedini, The Pope’s Elephant. An Elephant’s Journey from Deep in India to the Heart of Rome, Manchester 1997 (per questo studio si è consultata l’edizione Penguin, London 2000, 36-58).
106 Si vedano Bedini, The Pope’s Elephant, 53-55; Nair de Nazaré Castro Soares, "A carta de D. Manuel ao Papa Leão (1513)", in: Biblos 2 (2004), 99-130.
107 Mac Swiney de Mashanaglass, Le Portugal et le Saint-Siège, 31-32; Bedini, The Pope’s Elephant, 66-71.
108 Mac Swiney de Mashanaglass, Le Portugal et le Saint-Siège, 34; Bedini, The Pope’s Elephant, 71.
109 Si vedano di recente Cinzia Sicca, "Consumption and Trade of Art between Italy and England in the First Half of the Sixteenth Century: the London House of the Bardi and Cavalcanti Company", in: Renaissance Studies 16 (2002), n. 2, 163-201; Cinzia Sicca, "Florentine Sculptors at the Court of Henry VIII", in: Renaissance Studies 20 (2006), n. 1, 1-34; Giancarlo Gentilini e Tommaso Mozzati, "142 life-size figures … with the King on horseback. Baccio Bandinelli’s Mausoleum for Henry VIII", in: The Anglo-Florentine Renaissance. Art for the Early Tudors, ed. Cinzia Sicca and Louis A. Waldman, New Haven, CT 2012, 203-233; Tommaso Mozzati, "Baccio Bandinelli’s Model for the Tomb of Henry VIII: Context, Function, Significance", in: Creating Sculpture: the Drawings and Models of Renaissance Sculptors, ed. Michael Cole e Peta Motture, in corso di stampa.
110Si vedano J. Mainwaring Brown, "Henry VIII’s Book Assertio Septem Sacramentorum and the Royal Title of Defensor of Faith", in: Transactions of the Royal Historical Society 8 (1880), 242-261; Sheryl E. Reiss, "From Defender of the Faith to Suppressor of the Pope: Visualizing the Relationship of Henry VIII to the Medici Popes Leo X and Clement VII", in: The Anglo-Florentine Renaissance, ed. Sicca and Waldman, 235-264, qui 241-242.
111 Vasari, Le vite, V, 1984, 201.
112 Vasari, Le vite, V, 1984, 245.
113 Mac Swiney de Mashanaglass, Le Portugal et le Saint-Siège, 34-37; Bedini, The Pope’s Elephant, 72-77.
114 Reiss, "From Defender of the Faith", 238.
115 Pereira, "Armes divines", 52.
116 Dias, Nicolau Chanterene, 63-67.
117 Battelli, Il Sansovino in Portogallo, 8-12. Si veda anche Battelli, Andrea Sansovino e l’arte italiana, 18.
118 Firenze, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie degli Uffizi, inv. 142 A, penna e acquarello, 589 x 462 mm (dimensioni generali del disegno); il supporto cartaceo è composto da due fogli separati di diverse dimensioni: uno più piccolo montato in alto (186 x 462 mm), uno più grande in basso (413 x 462 mm).
119 Si vedano Albert Jahn, "Die Sammlung der Handzeichnungen italienischer Architekten in der Galerie der Uffizien in Florenz", in: Jahrbücher für Kunstwissenschaft 2 (1869), 143-154, qui 151-152; Pasquale Nerino Ferri, Indice geografico-analitico dei disegni di architettura civile e militare esistenti nella R. Galleria degli Uffizi in Firenze, Roma 1885, 146; Cornelius von Fabriczy, "Ein unbekanntes Jugendwerk Andrea Sansovinos", in: Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen 27 (1906), n. 2, 79-105, qui 98, nota 2; su questa individuazione, si veda anche Licia Collobi Ragghianti, Il Libro de’ disegni del Vasari, 2 voll., Firenze 1974, I, 107, II, 172, n. 326. Gustavo Giovannoni ne manteneva la paternità sansovinesca con una cronologia sul 1507–1513, pur slegandone la genesi dalla progettazione di simili sepolcri monumentali: Gustavo Giovannoni, "Un’opera sconosciuta di Jacopo Sansovino in Roma", in: Bollettino d’arte 11 (1917), n. 3-4, 64-81, qui 78-79.
120 Licia Collobi Ragghianti, "Il Libro de’ disegni del Vasari: disegni di architettura", in: Critica d’arte 20 (1972), n. 127, 3-120, qui 40; Licia Collobi Ragghianti, "Nuove precisazioni sui disegni di architettura del Libro del Vasari", in: Critica d’arte 20 (1973), n. 130, 31-54, qui pp. 31, 47; Collobi Ragghianti, Il Libro de’ disegni, I, 107, II, 172, n. 326.
121 Middeldorf, Raccolta, I, 226.
122 Tommaso Mozzati, in: Ritratto di un banchiere del Rinascimento. Bindo Altoviti tra Raffaello e Cellini, cat. mostra, ed. Alan Chong, Beatrice Paolozzi Strozzi e Dimitrios Zikos, Milano 2004, 387-388, cat. 11-11a.
123 Garrard, The Early Sculpture, 398-404.
124 Moreira, in: XVII Exposição Europeia, cat. 394, 318-319, lascia aperta l’ipotesi attributiva in favore del Tatti. Nel suo contributo "Andrea Sansovino au Portugal", 35-36, lo studioso propende invece per un riferimento ad Andrea. Si veda anche Moreira, "Andrea Sansovino em Lisboa", 114.
125 Höfler, "New Light", 236-237. Si accoda all’opinione di Höfler anche Heim, "Spurensuche in Spanien", 494.
126 Fattorini, Andrea Sansovino, 50-51, nota 24.
127 Huntley, Andrea Sansovino, 100-101.
128 Boucher, The Sculpture of Jacopo Sansovino, II, 359, cat. 77.
129 Grilo, "Andrea Sansovino e Nicolau Chanterene", 311.
130 Garrard, The Early Sculpture, 403-404. Nella bibliografia dedicata al disegno è singolare, ad esempio, che Middeldorf, Raccolta, I, 227, ne rifiuti il legame con le sepolture in Santa Maria del Popolo, non solo su basi stilistiche, ma anche perché vi mancherebbe "ogni emblema che si aspetterebbe sulla tomba di un cardinale": nello stesso contributo, lo studioso non avanza infatti un’obiezione analoga al riconoscimento nel foglio di un progetto per il sepolcro di un re portoghese.
131 Sui gisants nella tomba di João I e di Filipa de Lencastre, si veda Joana Ramôa Melo e José Custódio Vieira da Silva, "O retrato de D. João I no Mosteiro de Santa Maria da Vitória. Um novo paradigma de representação", in: Revista de História da Arte 5 (2008), 76-95.
132 Flaminia Bardati, "Non est enim potestas nisi a Deo: l’expression de la royauté chez les derniers Valois", in: La représentation sculpturale du pouvoir, atti del convegno (Parigi, 17-18 marzo 2016), ed. Sabine Frommel e Pawel Migasiewicz, in corso di stampa; Tommaso Mozzati, "Il re di Francia e le guerre d’Italia: François Ier, gli artisti toscani e l’immaginario bellico nei monumenti della monarchia", in: Il sogno d’arte di François Ier. L’Italie à la cour de France, ed. Louisa Capodieci e Gaylord Brouhot, Roma 2019, 187-212.
133 Si vedano Gisela Noehles-Doerk, "Die Realisation der Grabmalplanungen der Katholischen Könige", in: Grabkunst und Sepulkralkultur, ed. Borngässer, Karge e Klein, 379-402, qui 395-400; Miguel Ángel Léon Coloma, "Los mausoleos reales", in: La catedral de Granada: la Capilla Real y la iglesia del Sagrario, ed. Antonio Calvo Castellón et al., 2 voll., Granada 2007, I, 341-364; María José Redondo Cantera, "Los sepulcros de la Capilla Real de Granada", in: Juana I en Tordesillas. Su mundo, su entorno, ed. Miguel Ángel Zalama, Valladolid 2010, 185-214, qui 195-203; Michela Zurla, "Domenico Fancelli and the Tomb of the Catholic Kings: Carrara, Italian Wars and the Spanish Renaissance", in: Artistic Circulation between Spain and Italy: Cultural Exchanges in Early Modern Europe, ed. Kelley Helmstutler Di Dio e Tommaso Mozzati, New York 2019, 21-37.
134 Si veda in ultimo Tommaso Mozzati, "Charles V, Bartolomé Ordóñez, and the Tomb of Joanna of Castile and Philip of Burgundy in Granada", in: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 59 (2017), n. 2, 175-201, qui 181-185. Per il contratto si vedano José Maria Madurell Marimón, "Bartolomé Ordóñez (contribución al estudio de su vida artística y familiar)", in: Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona 6 (1948), n. 1-2, 345-373, qui 365-367; José María de Azcárate, Colección de documentos para la historia del arte en España, II: Datos histórico-artísticos de fines del siglo XV y principios del siglo XVI, Saragozza 1982, 130-131, n. 170.
135 Darr, Pietro Torrigiano, 195. Sulla tomba si vedano anche Alan Phipps Darr, "New Documents for Pietro Torrigiani and Other Early Cinquecento Florentine Sculptors Active in Italy and England", in: Kunst des Cinquecento in der Toskana, ed. Monika Cämmerer, Monaco di Baviera 1992, 108-138, qui 122; Alan Phipps Darr, "Pietro Torrigiani and His Sculpture in Henrician England: Sources and Influences", in: The Anglo-Florentine Renaissance, 49-80, qui 49-54. Fonti seicentesche testimoniano di come i gisants indossassero due corone, oggi perdute; Darr, Pietro Torrigiano, 180-181, 193, 196. In assenza di questi attributi è comunque difficile stabilire la loro origine e giudicare se fossero una più tarda addizione alle effigi. Ai piedi dei due monarchi sono accoccolati due leoni; Darr, Pietro Torrigiano, 180, 195, 197.
136 Darr, Pietro Torrigiano, 176, 181, 195.
137 Darr, Pietro Torrigiano, 193, 198.
138 Darr, Pietro Torrigiano, 177, 198. Sulla faccia occidentale della cassa compaiono un drago e un levriero (rispettivamente riferimenti al re gallese Cadwallader e ai casati Richmond e Beaufort) con una rosa Tudor al centro sormontata da una corona.
139 David Frapiccini, in: La forma del Rinascimento. Donatello, Andrea Bregno, Michelangelo e la scultura a Roma nel Quattrocento, ed. Claudio Crescentini e Claudio Strinati, Soveria Mannelli 2010, 350-351.
140 William Jones, Crowns & Coronations. A History of Regalia, London 1883, 73-74; Cyril Davenport, The English Regalia, London 1897, 17, 37. Si veda anche Martin Holmes e H. D. W. Sitwell, The English Regalia: Their History, Custody & Display, London 1972, 16.
141 Stefan Roller, in: Niclaus Gerhaert: Der Bildhauer des Späten Mittelalters, cat. mostra, ed. Stefan Roller, Francoforte 2012, 220-224, cat. 5.
142 Moreira, in: XVII Exposição Europeia, cat. 394, 319; si veda anche Höfler, "New Light", 236, nota 29.
143 Garrard, The Early Sculpture, 409, nota 46.
144 In rapporto all’attribuzione del foglio, il rimando vasariano in favore del Sansovino offre un’indicazione percorribile, almeno in termini di contesto produttivo; e certo per questo il dibattito si è incardinato sui nomi di Andrea e Jacopo. I loro rarefatti cataloghi grafici rendono però assai difficile esprimersi sulla paternità e sulla datazione del disegno, basandosi soltanto su una disamina stilistica. È però evidente, nella concezione d’insieme, il rapporto con due disegni a penna oggi concordemente riferiti ad Andrea, uno già a Weimar (ringrazio Hermann Mildenberger per le informazioni), l’altro a Londra (Victoria & Albert Museum, inv. 8621, 371 x 251 mm). Riconosciute da Middeldorf come progetti per le tombe Sforza e Basso della Rovere, queste opere sono di solito datate attorno al 1505 e costituiscono dei precedenti per il foglio degli Uffizi; Middeldorf, "Two Sansovino Drawings", 159-164. Tuttavia, quest’ultimo si caratterizza per una conduzione più libera degli elementi d’ornato scultoreo (secondo quanto sottolineato dallo stesso Middeldorf, Raccolta, I, 226). Si potrebbe allora pensare a una cronologia un po’ più tarda, spinta sul secondo decennio del secolo, senza potersi decidere in maniera conclusiva per la mano dell’uno o dell’altro scultore.
145 Oliveira e Costa, D. Manuel I, 198-202. Sulle richieste presentate da D. Manuel tramite i suoi ambasciatori nel corso della spedizione romana del 1514, si veda Bedini, The Pope’s Elephant, 63-64.
146 Mozzati, "Baccio Bandinelli’s Model for the Tomb of Henry VIII".
147 Sylvie Deswarte-Rosa, "Le Panthéon royal de Belém", in: Demeures d’éternité, 157-198. Si vedano anche Buescu, "Uma sepultura"; Neto, "La expresión condicionada", 363-369.